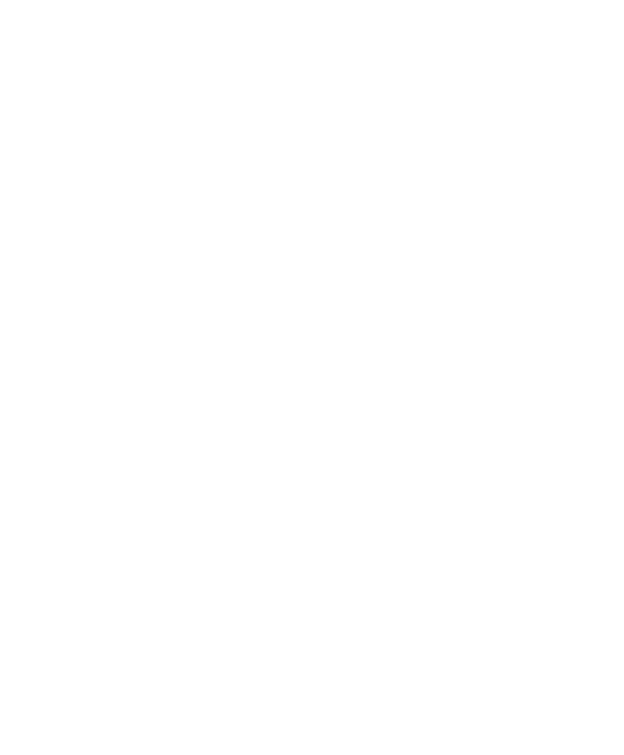Possiamo ancora accettare che l’in-clusione venga spesso sostituita da una re-clusione? Non è solo una questione di etica: il riconoscere che ogni operatore ha un suo potenziale valore per l’azienda diventa una leva per configurare sistemi produttivi sempre più competitivi.
Guido J.L. Micheli, Professore associato di Industrial Plants Engineering and Management
School of Management Politecnico di Milano
In ogni cosa esistono dei tempi minimi necessari perché una evoluzione cominci a dare qualche effetto. Nel nostro Paese la costituzione recita che l’Italia è una “Repubblica […] fondata sul lavoro”, tuttavia solo negli ultimi decenni si è cominciato ad affrontare in qualche modo il problema dell’inclusione lavorativa degli operatori disabili, che – salvo rarissimi casi – non presentano le caratteristiche “standard” che le aziende ricercano nei propri impiegati.
Semplificando, il processo si muove attualmente su due fronti. Da una parte, un grande numero di aziende è obbligato per legge ad assumere operatori disabili; dall’altra, esistono aziende (le cooperative sociali di tipo B) il cui fine ultimo è quello di preparare al lavoro persone disabili (anche dette, in questo caso, “svantaggiate”). Nella grande casistica delle aziende che sono obbligate ad assumere personale disabile, la deriva assai frequente è alternativamente l’assunzione di una persona che viene poi “isolata” in compiti di poco valore per l’azienda stessa (in altre parole, assunti ma non inclusi) oppure la scelta deliberata di pagare le penali annesse alla non assunzione, considerate paradossalmente “sostenibili” se confrontate con l’onere della gestione di una persona considerata di poco valore aggiunto.
Perché questa situazione? La motivazione è, tutto sommato, abbastanza semplice: le aziende sono abituate e vogliono continuare a lavorare in situazioni in cui ogni attività, macchina, attrezzatura, luogo, processo è progettato per persone “standard”. Ogni differenza è vissuta come origine di inefficienza.
È senz’altro vero che la formazione iniziale e continua degli operatori disabili è in certi casi significativamente maggiore, ma perché? Una delle risposte è facilmente identificabile: lo sforzo nella formazione/preparazione degli operatori disabili a qualsivoglia mansione lavorativa è collegato all’obiettivo stesso di tale formazione, ossia fornire loro le stesse capacità di operatori non disabili. In altre parole, anche la formazione che le aziende immaginano e mettono in pratica non è inclusiva, bensì volta ad uniformare gli operatori disabili agli altri.
Cosa occorrerebbe fare per cambiare lo status quo?
Serve un profondo cambiamento culturale. Le aziende devono studiare criticamente i propri processi, per identificarne le porzioni che possano essere svolte con caratteristiche “diverse”; così facendo, tali “caratteristiche diverse” non richiedono più uno sforzo per essere adeguate e incluse, ma diventano naturalmente funzionali, e quindi naturalmente incluse.
Questo tipo di analisi è ciò che le cooperative sociali (aziende manifatturiere o agricole vere e proprie, che impiegano primariamente operatori disabili) devono necessariamente fare ogni giorno, per capire ad esempio come un processo di assemblaggio possa essere “suddiviso e supportato” per essere efficientemente ed efficacemente svolto da operatori disabili, spesso diversissimi fra loro.
Questa attenzione ai processi porta come effetto secondario una semplificazione degli stessi, e quindi una riduzione degli errori, che si traduce in una riduzione degli scarti, e complessivamente in un aumento dell’efficienza.
Allora, l’avere coscienza che in azienda tutti sono “diversi”, può diventare un’importante leva di cambiamento: ogni attività, macchina, attrezzatura, luogo, processo, che una volta erano progettati per persone “standard”, possono essere finalmente progettati in maniera operatore-centrica e non standard-centrica.
A cosa serve la flessibilità dei componenti dei sistemi produttivi (macchine, linee, ruoli, …), tanto ricercata negli ultimi decenni, se poi non viene usata in modo continuativo per rivedere i processi e le mansioni, alla ricerca di una sempre migliore configurazione complessiva del sistema? Se questo fosse l’approccio, l’inclusione non sarebbe più da ricercare come tale.
Stiamo comprendendo che l’inclusione non può essere forzata: se viene imposta, come da approccio legislativo , in molti casi si trasforma in reclusione. Invece, il riconoscere che ogni operatore ha un suo potenziale valore per l’azienda diventa una leva per configurare sistemi produttivi e renderli sempre più competitivi.
D’altronde, chi di noi non ha mai pensato “ho in mente la persona giusta per questo”? Ecco, si tratta semplicemente di cominciare a riconoscere in tutte le persone – comprese quelle disabili – i rispettivi punti di forza.
Partiamo da qui. E non chiudiamo gli occhi: qualche azienda già lo fa!