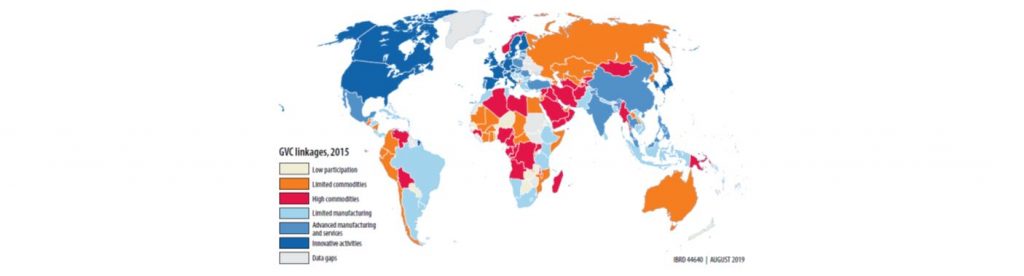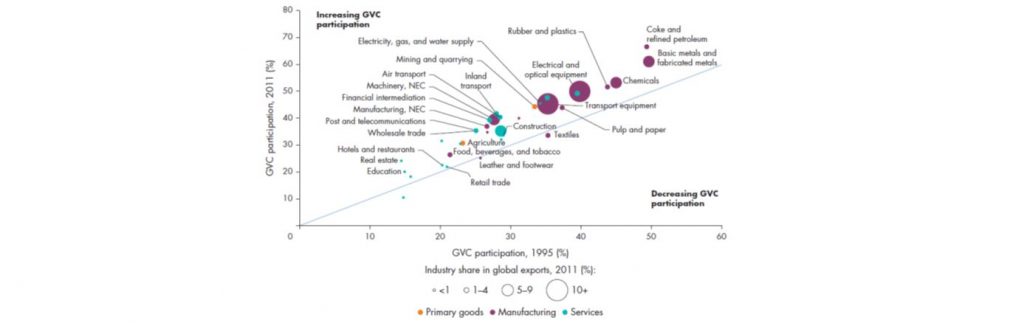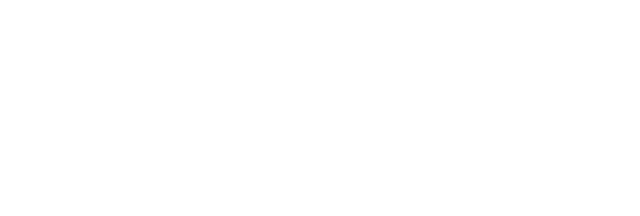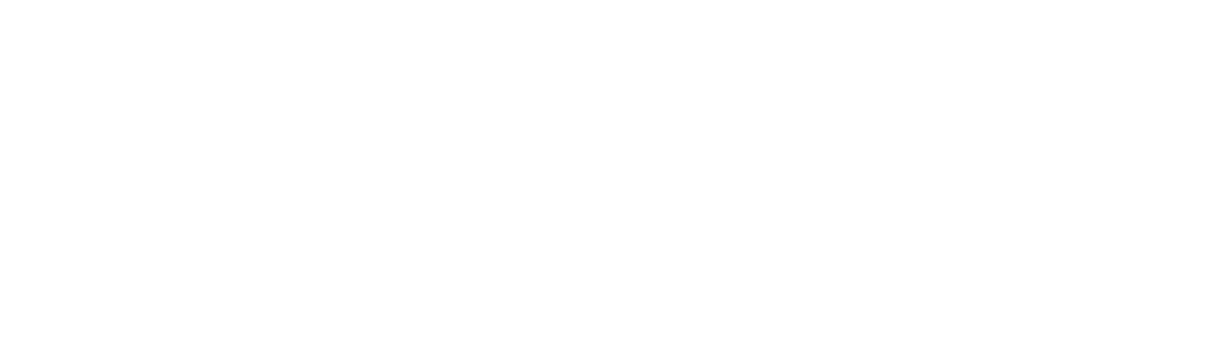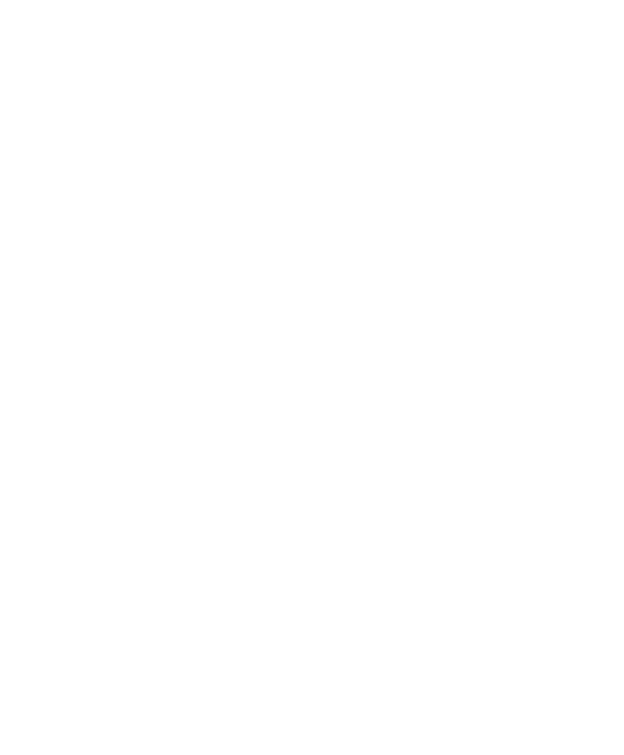Un cambiamento di paradigma che andrà oltre la stagione Autunno Inverno 20/21.
Alessandro Brun, Professore di Quality Management, Direttore del Global Executive Master of Luxury Management e fondatore Sustainable Luxury Academy
Co-autrice Cecilia Castelli, Extended Faculty MIP Graduate School of Business
School of Management Politecnico di Milano
L’emergenza legata alla pandemia del virus Covid-19 è lungi dall’essere finita, e già molti esperti sono concordi nel prevedere che vi saranno impatti significativi sull’industria del lusso che andranno ben oltre il breve termine, in quanto la quarantena potrebbe portare a cambiamenti duraturi nel comportamento di acquisto dei clienti del segmento top di gamma: meno viaggi e più occasioni sociali tra le mura domestiche; un consumo più responsabile, che privilegi oggetti di qualità e produzioni locali, ma con attenzione al portafoglio; e gli acquisti online che cresceranno ulteriormente…
I più importanti player del settore hanno già iniziato a rivedere le loro strategie, alla luce del fatto che – come già avvenuto nelle precedenti crisi globali – le minacce legate a cambiamenti strutturali nel mercato potrebbero per alcuni trasformarsi in opportunità.
L’effetto delle chiusure
Nel recente Luxury Study Spring 2020, Bain&Co e Altagamma [1] prevedono un 2020 con una riduzione del giro d’affari tra il 20% (nel migliore degli scenari – quello che vede una ripresa importante già dal terzo quarter) e il 35% (qualora gli effetti negativi della pandemia si trascinassero a lungo) per i cosidetti “personal luxury goods”, ovvero quelle categorie su cui si sono concentrati negli scorsi anni gli acquisti aspirazionali di una classe media in cerca di legittimazione. Già quando la crisi muoveva i primi passi, l’indagine di BCG e Altagamma[2] prospettava una contrazione importante, con un valore complessivo che ci riporta ai livelli del 2015 e una riduzione dei margini oltre il 13%. Nonostante la ripartenza del Dragone Asiatico, quindi, sembra che i numeri delle prime analisi vengano confermati. Numeri impressionanti, che – nello scenario più pessimistico – in valore assoluto corrisponderebbero ad un calo di fatturato di quasi 100 miliardi di € per i soli beni personali di lusso, e che sintetizzano difficoltà non trascurabili per tre categorie di attori:
- Retailer finanziariamente molto esposti, che si trovano in carico buona parte della collezione Primavera-Estate 2020, invenduta e probabilmente invendibile;
- Player di piccole dimensioni, su cui gli impatti di una chiusura prolungata possono essere devastanti;
- Attori a monte delle filiera, che nel migliore dei casi sono messi in difficoltà da dilazioni a tempo indeterminato dei pagamenti e contestuale assenza di ordini.
I cambiamenti nel comportamento di acquisto
Con la ripresa, il mercato non sarà più quello di prima. Nella nostra indagine abbiamo intervistato una dozzina di manager delle aziende del lusso e numerosi consumatori, e abbiamo ricevuto conferme sui cambiamenti più verosimili:
- Patrimonio, non reddito – con l’avvento del cosiddetto “Mass Marketing of Luxury”[a], i brand di lusso hanno spostato il target principale al ceto medio. Nello scenario ha caratterizzato gli ultimi due decenni, gli HENRY di tutto il mondo hanno speso una frazione significativa del proprio “disposable income” in beni ed esperienze di lusso[b], ma, dopo il lockdown, le famiglie della classe media potrebbero aver limitate disponibilità finanziarie da dedicare ad acquisti non di prima necessità, mentre gli HNWI si troverebbero con una capacità di spesa non modificata. Una dozzina di anni fa svolgemmo una ricerca nel mercato delle auto di lusso, per capire se la crisi dei mercati finanziari avesse portato ad una perdita di vendite o ad uno spostamento in avanti nel tempo delle stesse. Un giovane banker londinese dichiarò che si sarebbe dovuto comprare una Ferrari con il bonus di fine anno – niente bonus, e l’acquisto della Rossa di Maranello sfumò. Un imprenditore italiano dichiarò di aver rinunciato all’acquisto di una Maserati per “solidarietà” con i propri dipendenti – anche se, nonostante la crisi aziendale, il patrimonio di famiglia gli avrebbe permesso acquisti ben più consistenti di una berlina del tridente. In questo caso, l’acquisto venne semplicemente posticipato a momenti migliori. Lo stesso potrebbe succedere nel post-Covid: i brand e le categorie di beni di lusso che hanno come target il patrimonio soffriranno di meno.
- Per chi continua a rimanere a casa. Le riduzioni di viaggi – legate a restrizioni normative che potrebbero perdurare a lungo, paura di nuovi contagi, sostituzione di meeting di persona non strategici con più efficienti videoconferenze – porteranno ad una riduzione del fatturato di canali specifici (travel retail), destinazioni specifiche (e.g. Las Vegas), di segmenti specifici di mercato nei flagship store delle capitali mondiali del lusso (Cinesi in visita a Parigi, Milano, Londra per turismo o viaggio d’affari) e di categorie di prodotto quali trolley e valigie. Per contro, il fatto di continuare a rimanere a casa potrebbe trasformarsi in una opportunità per altre categorie quali Art de La Table, che negli ultimi hanni ha sofferto di un tasso di crescita ridotto rispetto alla media del comparto lusso[c]. Nelle categorie che a Marzo 2020 hanno avuto il maggior incremento di vendite su internet[d], seconde dopo ai guanti usa e getta, troviamo le macchine per fare il pane (+652% rispetto a Marzo 2019). Con il ritorno alla normalità, questo ritorno forzato ai fornelli potrà portare a maggior occasioni sociali tra le mura domestiche. I brand che ne sapranno approfittare, potranno spingere su acquisti in servizi tavola (per chi ospita), fiori, vini, superalcolici (per chi è ospitato). Della paura di viaggiare su mezzi pubblici, inoltre, potrebbe beneficiare anche la mobilità personale – automotive, ma magari anche yacht e jet privati.
- Appagamento personale – Sin dai tempi più lontani, i beni di lusso hanno costituito acquisti emotivi fatti da una clientela abbiente “per sentirsi meglio”. Dopo i sacrifici della quarantena, i consumatori torneranno ad avere voglia di spendere, ma lo faranno privilegiando l’esperienza edonistica al possesso materiale; peraltro, anche dopo un allentamento della quarantena, le occasioni di vita sociale potrebbero rimanere rarefatte per un periodo di tempo piuttosto lungo, e quindi beni e brand di lusso che prima della crisi venivano prevalentemente acquistati in quanto “Social Marker”[e] potrebbero lasciare il posto a brand meno appariscenti o a esperienze particolarmente intense (fine food & drinks, beauty, SPA e centri benessere, …).
- Lusso Responsabile – l’ineluttabilità del contagio e della Perdita di persone care ha portato molti ad interrogarsi su temi quali “dove sta andando l’umanità?”. La crescente sensibilità verso temi di sostenibilità ambientale e sociale non potrà che risultarne ulteriormente rinforzata; i brand e le categorie di prodotto (ad esempio beni artigianali piuttosto che industriali) che permettano un “consumo responsabile” verranno privilegiati. Giorgio Armani ha scritto una lettera aperta a WWD[f], nella quale lo stilista italiano ringrazia l’autorevole magazine per aver alimentato il dialogo su quanto assurdo sia l’attuale stato delle cose – caratterizzato da sovrapproduzione di abiti e un “disallineamento criminale” tra la stagione metereologica e quella commerciale.
- Alla ricerca di saldi e sconti – se, da un lato, ci possiamo aspettare un’ondata di anti-consumismo, l’abitudine di aspettare i saldi o di fare pellegrinaggi ai c.d. Factory Outlet verrà esacerbata dal generale autorichiamo alla frugalità[g]. Se brand e retailers dovessero ricorrere a pesanti scontistiche per liberarsi dello stock della stagione PE 2020, rischierebbero di alimentare ulteriormente il circolo vizioso dell’attesa dei saldi.
- Online per vendere, per comunicare, per intercettare – durante il lockdown, siamo tutti testimoni in prima persona di come la transizione ad una vita nel mondo digitale abbia subito un salto quantico. I consumatori acquistano di più online, consumano più contenuti digitali, e in generale trascorrendo più tempo online sono più propensi al dialogo con le aziende. I brand del lusso dovranno rivedere la propria strategia digitale, per cogliere la triplice opportunità di incrementare le vendite del canale eCommerce, incrementare la frequenza e la profondità della comunicazione ai propri clienti, e raccogliere un prezioso bottino di informazioni con il quale arricchire il proprio database CRM[h].
- Un rinnovato senso di orgoglio per le produzioni locali – questo purtroppo potrebbe dipendere dallo specifico mercato, ma già si sono visti i primi segni che presagiscono la nascita di veri e propri movimenti di “buy local”.
In conclusione, senza dubbio vedremo un ruolo diverso dei canali di vendita: la crescita costante del travel retail si fermerà inevitabilmente; si consoliderà l’abitudine di acquistare online, soprattutto per quei clienti che spinti dall’emergenza hanno superato le barriere psicologiche, con un boost double digit quanto più anche le attività branding si sposterà online; il ruolo delle boutique fisiche sarà certamente da ripensare; i canali discount dovranno essere gestiti con attenzione per mantenere un posizionamento coerente del band pur andando a catturare quel 56% di clienti che (secondo il report BoF-Mc Kinsey) andranno a caccia di occasioni. In questo tipo di scenario, assumerà un ruolo ancora più importante la comunicazione – non solo di brand e prodotto, ma anche il racconto delle strategie che si stanno mettendo in atto sia per rispondere all’emergenza sanitaria che per dare solidità al business – che deve essere vista come un investimento prioritario.
_________________________________________________________
[1] L. Zargani. Personal Luxury Goods expected to contract 20% to 35% in 2020. Women’s Wear Daily, 7 Maggio 2020 https://wwd.com/business-news/business-features/personal-luxury-goods-expected-to-contract-20-to-35-in-1203628347/
[2] A. Biondi. Coronavirus could cause a €40 billion decline in luxury sales in 2020. Vogue Business, 21 Febbraio 2020 https://www.voguebusiness.com/companies/coronavirus-luxury-brands-impact-sales-altagamma
[a] Nueno e Quelch. “The Mass Marketing of Luxury”. Business Horizons, Novembre-Dicembre 1998
[b] Silverstein e Fiske. Trading up: the new American Luxury. Penguin Group, 2003
[c] S. Lazzaroni. Altagamma Consensus 2019 – June update. Altagamma, Giugno 2019
[d] J. Styrk. The top 100 fastest growing and declining categories in eCommerce. Stackline, 31 Marzo 2020
[e] Kapferer e Bastien. The Luxury Strategy: break the rules of marketing to build luxury brands. Kogan Page publishers, 2012.
[f] L. Zargani. “Giorgio Armani writes open letter to WWD”. WWD, April 3rd, 2020
[g] Amed, Berg, Balchandani, Hendrich, Rölkens, Young, Jensen. The State of Fashion 2020: Coronavirus Update. BoF e McKinsey&Company
[h] M. Nicolelli. The Covid-19 Carousel. Challenges and Disruptions in the Fashion Luxury Sector. Hydra Advisory.