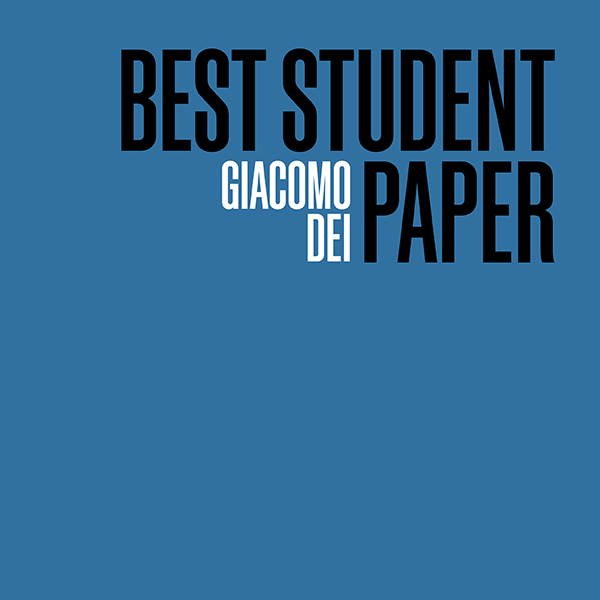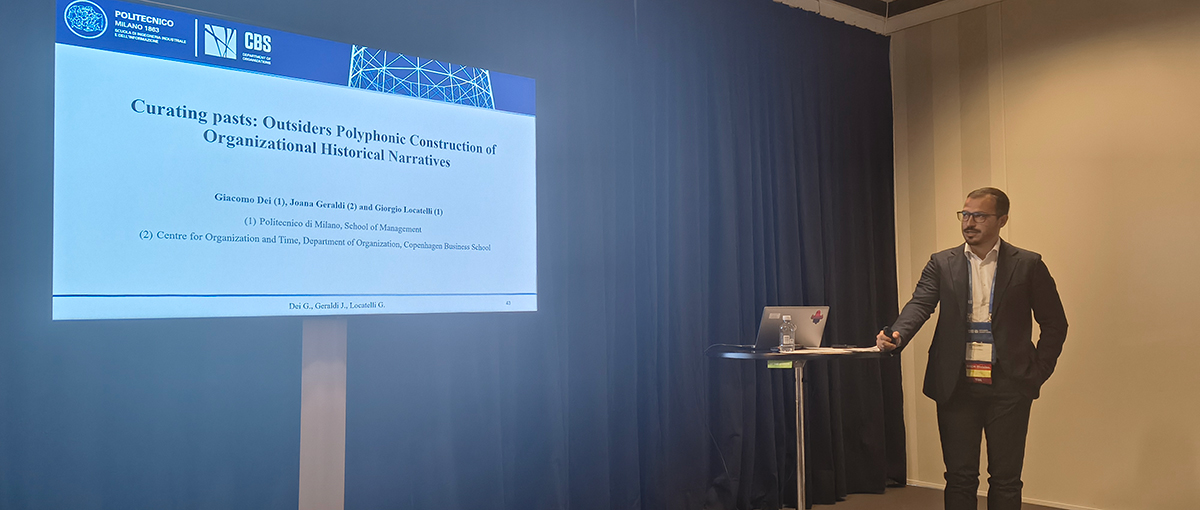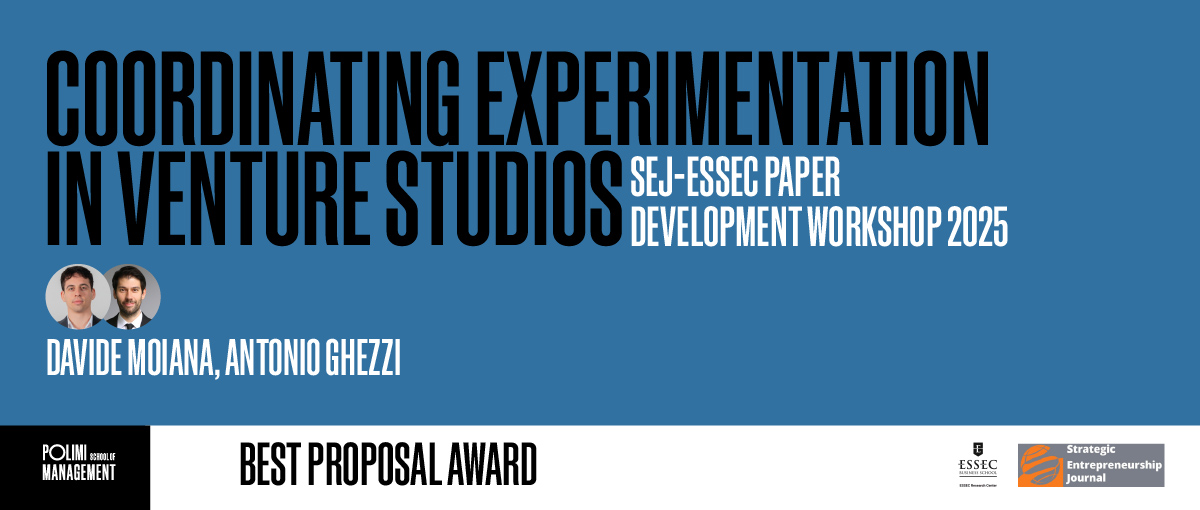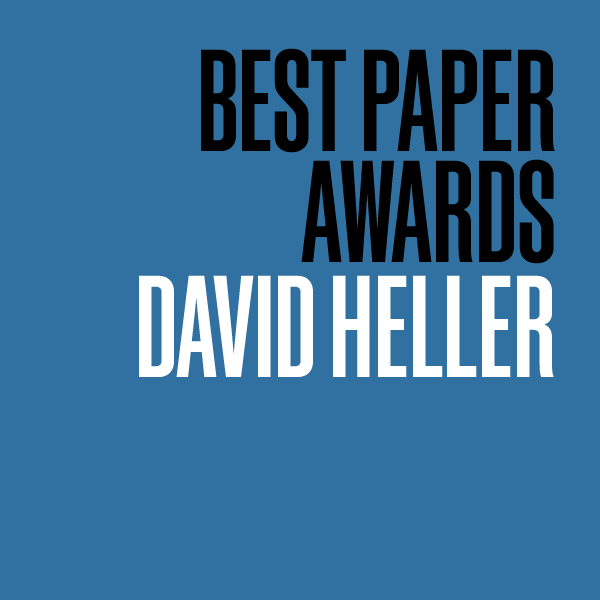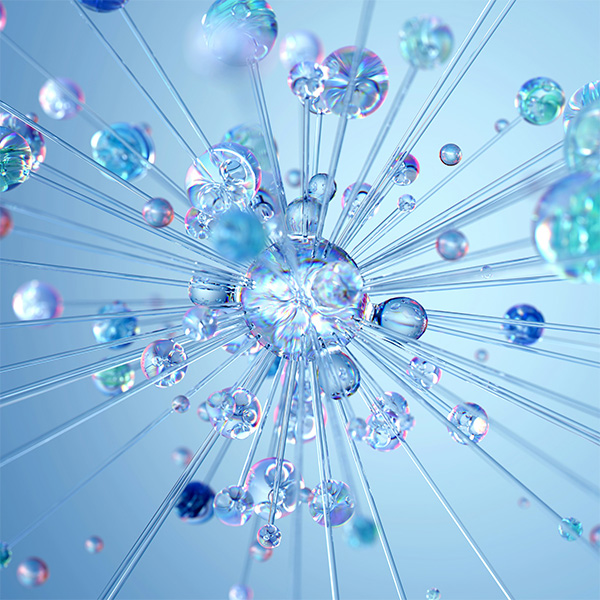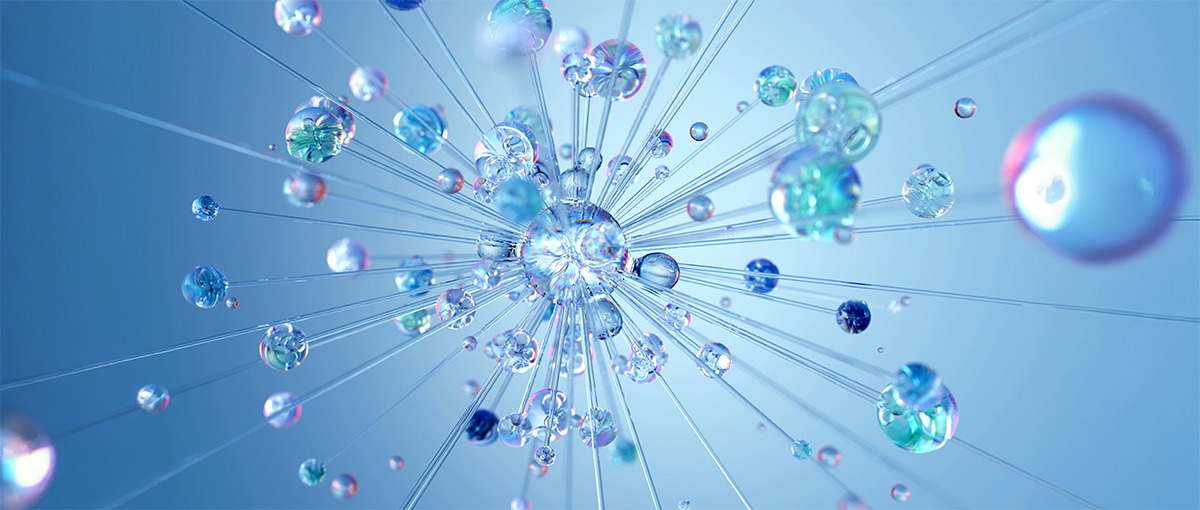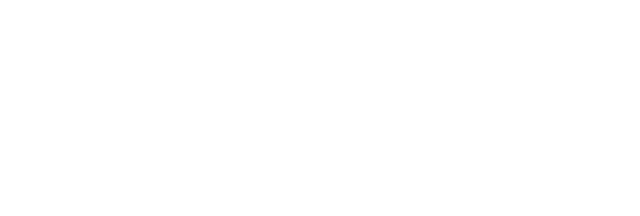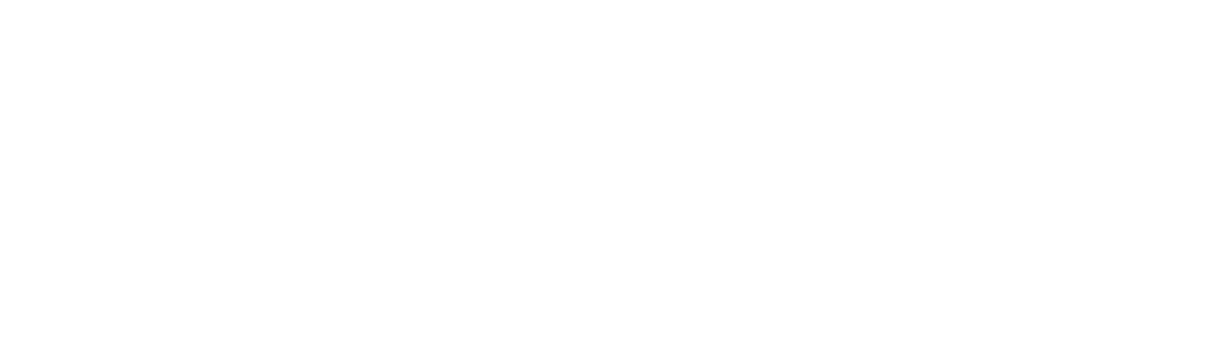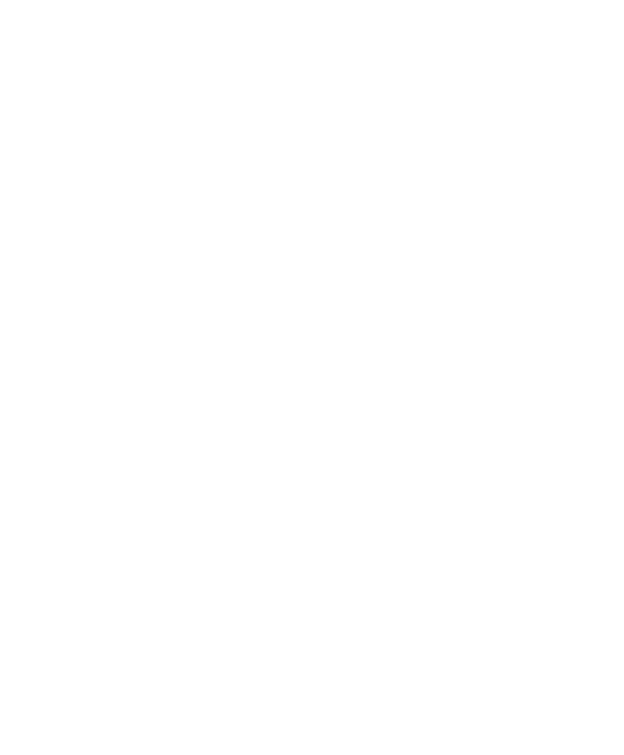La POLIMI School of Management conferma la propria eccellenza internazionale posizionandosi al 31° posto al mondo nella classifica Financial Times Research Insights 2025, che misura la capacità delle business school di produrre ricerca con un impatto reale su imprese, istituzioni e società.
La classifica valuta la qualità, la rilevanza e la diffusione della ricerca accademica in 179 business school internazionali, analizzando la produzione scientifica pubblicata tra il 2020 e il 2025.
Oltre alle citazioni accademiche tradizionali, il Financial Times considera una serie di indicatori più ampi:
- la credibilità dei lavori attraverso l’indice di citazioni positive Scite (ovvero, citazioni in cui altri studiosi confermano la validità del lavoro),
- gli studi relativi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) delle Nazioni Unite,
- l’impatto sulle politiche pubbliche e sulla pratica professionale,
- la visibilità mediatica e online, misurata tramite strumenti come Overton, Altmetric e la piattaforma SSRN,
- la produttività normalizzata in base alle dimensioni del corpo docente.
Nel ranking 2025, la POLIMI School of Management si distingue per un risultato di eccezione: il 2° posto al mondo nella ricerca legata agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante della School nel promuovere una ricerca capace di coniugare rigore accademico e impatto sociale, contribuendo alla conoscenza su temi cruciali come la sostenibilità ambientale, l’inclusione e l’innovazione responsabile.
Con questi risultati, la POLIMI School of Management si conferma tra i principali protagonisti europei nel campo della ricerca manageriale, impegnata nello sviluppo di una conoscenza rigorosa, rilevante e responsabile, al servizio dell’innovazione sostenibile e del progresso di imprese e società.