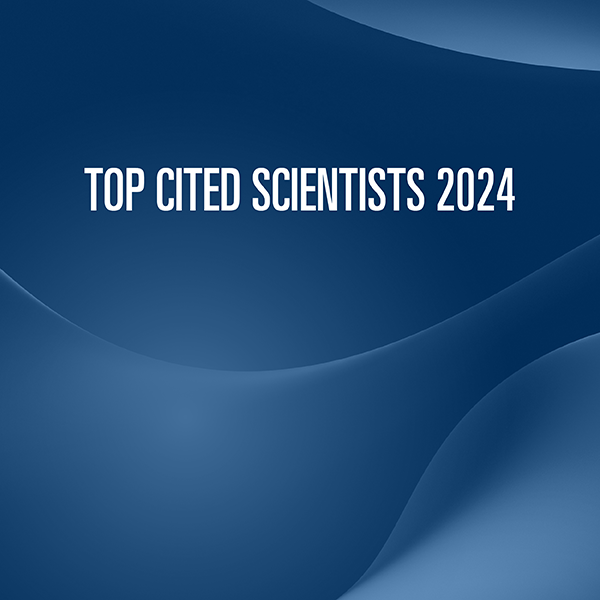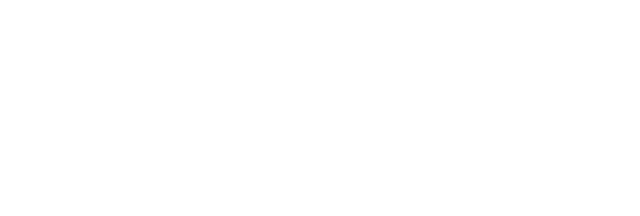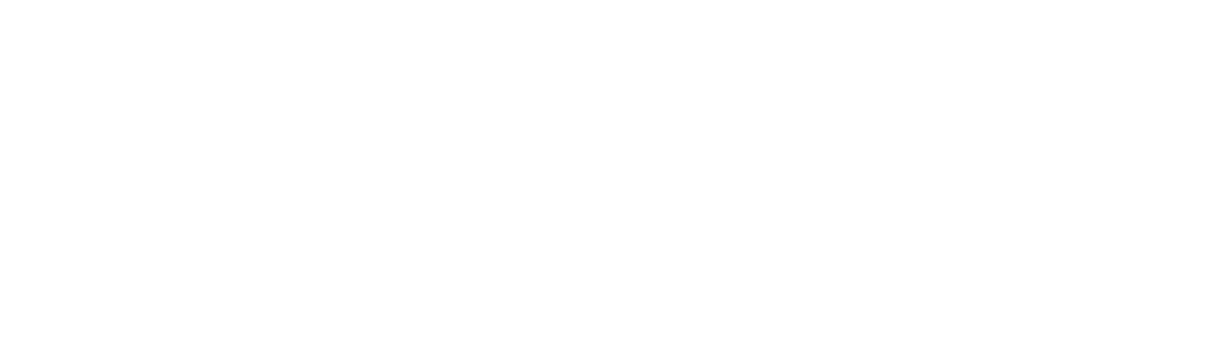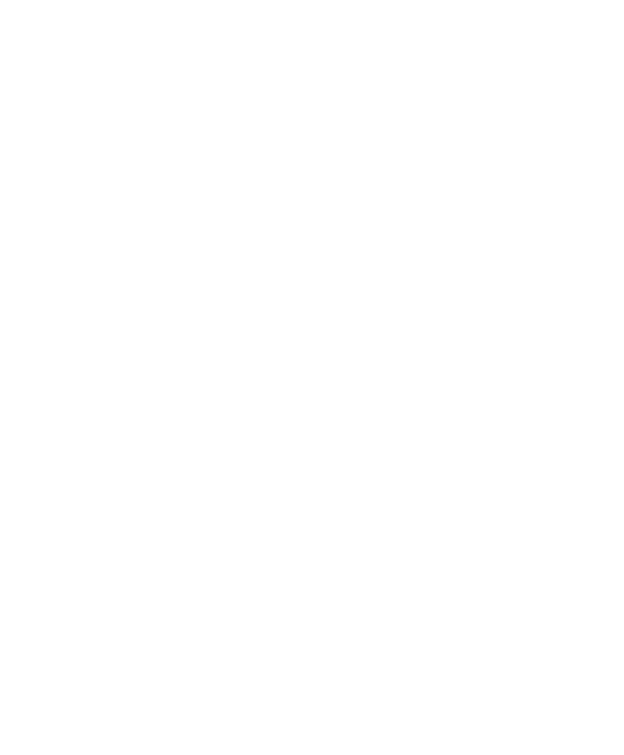Dal 2016 la School of Management (SoM) del Politecnico di Milano promuove la cultura della valutazione e del miglioramento dell’impatto della ricerca su istituzioni, aziende, studenti e docenti, cittadini e comunità accademica
Federico Caniato, Professore Ordinario di Supply Chain & Procurement Management, School of Management, Politecnico di Milano
Stefano Magistretti, Assistant Professor di Innovation & Design Management, School of Management, Politecnico di Milano
Sempre più spesso oggi viene messo in discussione il contributo che le università forniscono alla società, per cui sempre più spesso si richiede loro di misurare e dimostrare tale contributo, spesso definito “impatto”. L’approccio tradizionale è stato quello di identificare tre grandi missioni: ricerca, formazione e la cosiddetta “terza missione”, termine ampio che include le interazioni con la società in generale, ad esempio il trasferimento tecnologico, la promozione culturale, la comunicazione esterna. Vi è però un limite in questo approccio, in quanto rischia di vedere le tre missioni come attività separate, ognuna con le proprie regole e metriche.
Dal 2016 la School of Management (SoM) del Politecnico di Milano sta lavorando su questo tema con un approccio più integrato, che non vede le tre missioni come separate, ma piuttosto la ricerca come motore che può generare impatto su molteplici domini, non solo la comunità accademica e gli studenti, ma la società in generale. Per questo motivo promuoviamo la cultura della valutazione e del miglioramento dell’impatto della ricerca, in linea con la nostra mission:
“contribuire al bene collettivo attraverso una comprensione critica delle opportunità offerte dall’innovazione. Questa missione si realizza creando e condividendo la conoscenza attraverso un’istruzione di alta qualità, una ricerca di alta qualità e un impegno attivo con la comunità“.
Quando abbiamo iniziato questo cammino, abbiamo prima di tutto voluto incoraggiare tutti i colleghi a riflettere sull’impatto dei loro progetti di ricerca a 360 gradi. Nei primi anni, ci siamo occupati di stimolare il pensiero critico e la creazione di una cultura della misura dell’impatto. Inizialmente non era scontato che ogni progetto, dal più semplice al più complesso, dal più breve al più lungo potesse avere un impatto su diverse aree della mission della nostra scuola. Questa cultura della misura era ed è tutt’oggi però fondamentale per valutare e dimostrare l’impatto su molti domini e non solo sugli indicatori più tradizionali (e.g., numero di pubblicazioni academiche, numero di pubblicazioni su testate giornalistiche).
Per questo motivo abbiamo sentito la necessità di sviluppare un nostro modello per guidare la valutazione dell’impatto all’interno di tutta la SoM, che ci permettesse di perseguire i seguenti obiettivi:
- Aumentare la consapevolezza di tutta la nostra comunità
- Imparare a valutare l’impatto della ricerca
- Incoraggiare tutti i colleghi a progettare, condurre e diffondere ricerche volte ad avere un impatto misurabile
- Migliorare la capacità di rendere conto dell’impatto generato
- Riconoscere i risultati della ricerca della SoM
- Diffondere i risultati della ricerca sia all’interno della SoM sia all’esterno
Per raggiungere questi obiettivi, abbiamo costruito un modello, ispirato alla letteratura scientifica, che identifica 5 domini e 3 livelli di maturità di impatto della ricerca.
I 5 domini rispetto ai quali viene misurato l’impatto sono:
- Le istituzioni
- Le imprese
- Gli studenti e i docenti
- I cittadini
- La comunità accademica
L’impatto su ciascun dominio è poi misurato su una scala di maturità crescente a 3 livelli:
- Comunicazione dei risultati della ricerca
- Adozione dei risultati della ricerca
- Benefici ottenuti tramite l’adozione
Questo modello è volutamente generale, affinché possa essere adattato ai diversi temi e tipologie di ricerca della SoM. Per ciascun dominio e ciascun livello di maturità, è necessario identificare precisi indicatori, possibilmente quantitativi (e.g., numero di partecipanti a eventi, numero di articoli in rivista pubblicati, numero di conferenze academiche organizzate), che permettano di misurare e dimostrare l’impatto. Tali indicatori devono essere scelti coerentemente con la natura di ciascun progetto di ricerca.
Il modello è stato dapprima testato da alcuni colleghi che nel 2019 hanno valutato 16 progetti su queste dimensioni. Questo ha permesso di comprendere la solidità e validità del modello e identificare numerose metriche utili per i diversi domini e i diversi livelli di maturità.
Nel 2020 abbiamo investito nel coinvolgimento di tutta la SoM nel compiere questo importante esercizio, allargando così la partecipazione, arrivando a raccogliere il Research Impact Assessment per 42 diversi progetti condotti all’interno della SoM, di cui almeno uno per ciascuna linea di ricerca della Scuola.
E’ stata prima di tutto un’occasione formativa e di riflessione sul tema per tutta la scuola, per cui sono stati organizzati momenti di confronto e discussione. La sintesi e le evidenze principali sono state raccolte in un Booklet, che presenta una grande ricchezza e varietà di impatti e che servirà inizialmente come strumento di comunicazione interna per creare consapevolezza e raccogliere best practice.
Il lavoro continua, è già partita la raccolta per il 2021, con l’obiettivo di aggiornare le informazioni sui 42 progetti e ampliare ulteriormente la partecipazione.
La speranza e l’augurio è che questo esercizio permetta sempre più non solo di misurare a posteriori, ma anche di pianificare sin dall’inizio l’impatto dei progetti di ricerca, e spinga a coprire tutti i domini e a raggiungere il massimo livello di maturità possibile, ovvero quello dei benefici concreti.