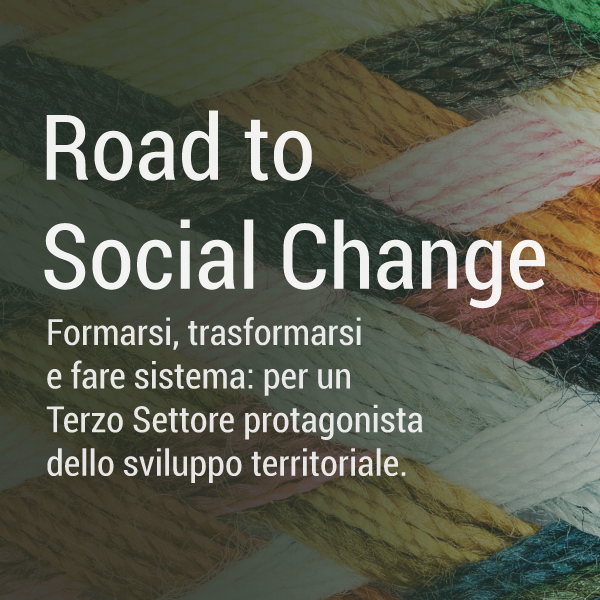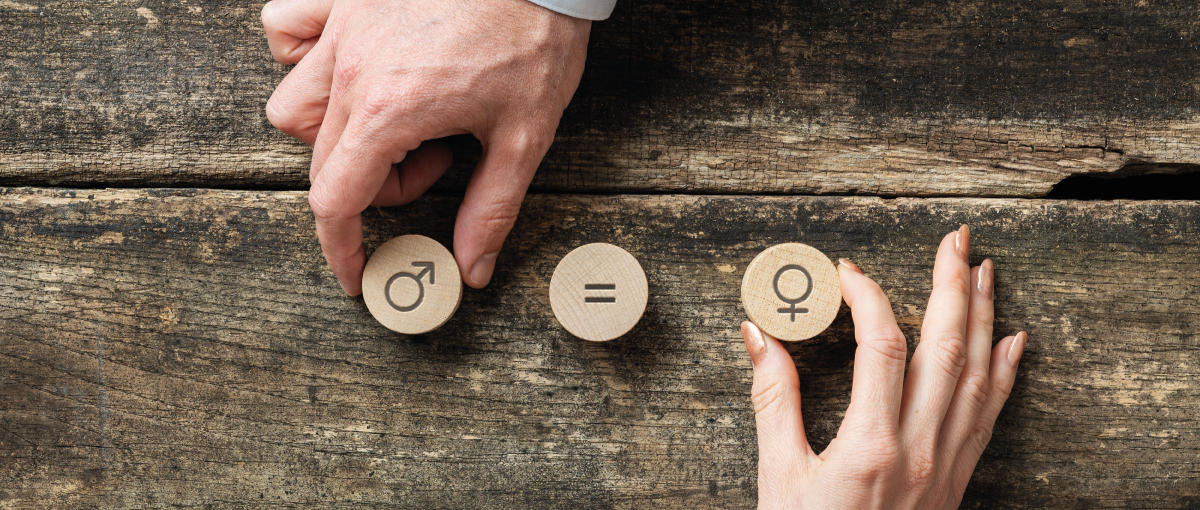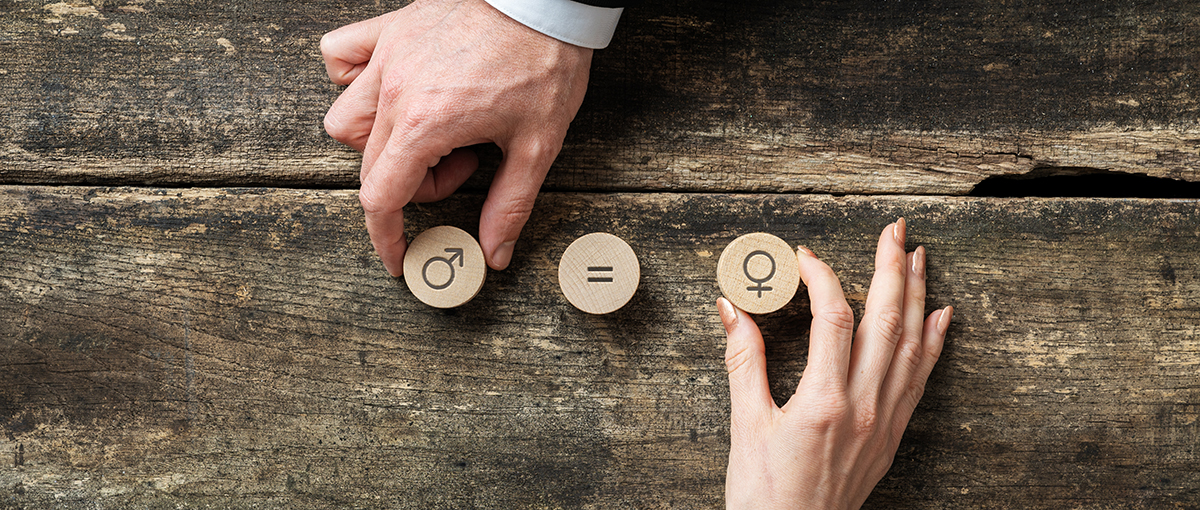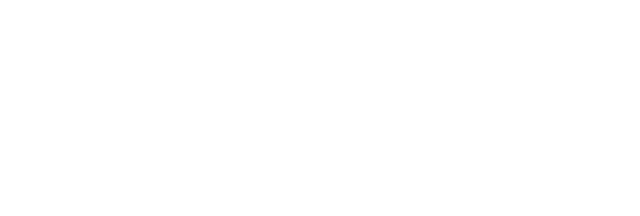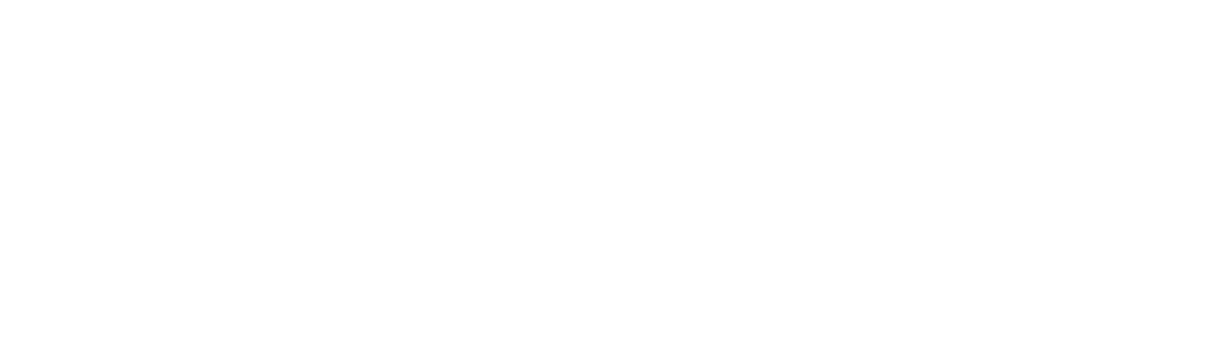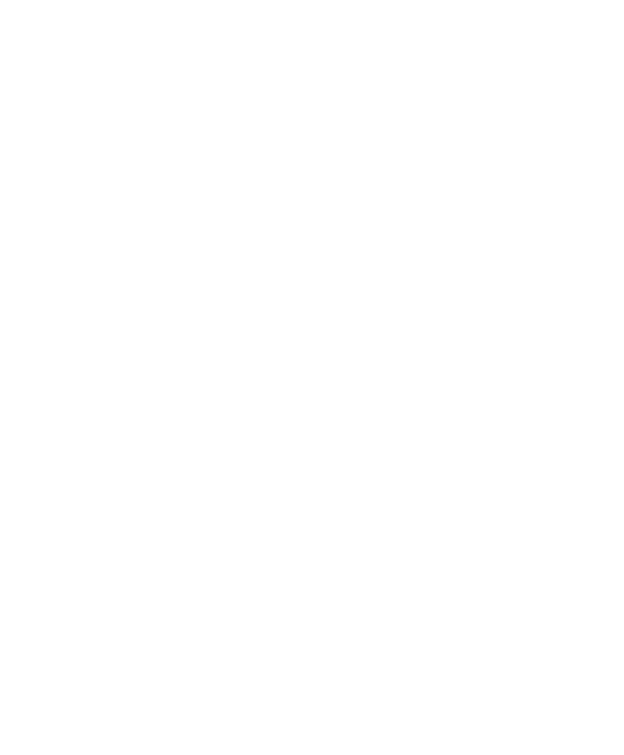Chateau d’Ax e la School of Management del Politecnico di Milano hanno realizzato un project work nel quale gli studenti hanno risposto con progetti e strategie ad una challenge reale proposta dalla storica azienda nel settore dell’arredamento. L’azienda ha selezionato i tre migliori progetti tra i 258 realizzati.
La collaborazione tra università e aziende è di importanza strategica sia per l’occupabilità dei futuri laureati, sia per le aziende che sempre più si rivolgono agli atenei per ottenere analisi e proposte di tipo strategico e innovativo. La challenge organizzata ogni anno all’interno del corso di Laurea Magistrale di Strategy & Marketing di Ingegneria Gestionale è un esempio concreto che permette ai laureandi di confrontare le competenze maturate durante il percorso di studi con le attività delle imprese: una sfida lanciata dall’azienda a cui gli studenti devono rispondere progettando soluzioni innovative utilizzando a supporto gli elementi teorici appresi durante il corso.
Per quest’anno accademico, la School of Management ha scelto di collaborare con Chateau D’Ax. “Abbiamo deciso di coinvolgere Chateau d’Ax e il settore dell’arredamento – spiega Francesca Capella, project manager del progetto e research fellow del Politecnico – perché si tratta di uno dei settori ai quali la pandemia ha richiesto maggiormente di reinventarsi, di definire nuove strategie di posizionamento e un nuovo approccio al mercato per rimanere competitivi nonostante il momento di difficoltà.”
Sono più di 250 i project work sviluppati dagli studenti per Chateau D’Ax che hanno preso in considerazione gli ambiti di maggior interesse per lo sviluppo dell’azienda all’interno di un mercato complesso e in rapido mutamento: materie prime e sostenibilità, economia circolare, innovazione di prodotto, esposizione del prodotto e, infine, comunicazione.
“Abbiamo aderito volentieri alla proposta del Politecnico di Milano perché crediamo molto nella collaborazione tra industria e università e che il suo sviluppo possa contribuire concretamente a formare una classe dirigente migliore e più preparata. – racconta Alessandro Colombo, direttore generale di Chateau d’Ax – Abbiamo condiviso con gli studenti gli ambiti nei quali si sviluppa la nostra strategia e abbiamo lasciato liberi i ragazzi di sviluppare le loro visioni”.
“Abbiamo selezionato 10 progetti su un totale di 258 – prosegue Capella – in base all’innovatività dell’idea, alla struttura della proposta sviluppata e alla capacità di utilizzare tool e costrutti teorici applicati ad una challenge di business reale. I progetti sono stati presentati dagli studenti stessi al management di Chateau d’Ax che li ha commentati ad uno ad uno dando agli studenti preziosi consigli di esperienza di vita aziendale”.
Continua Alessandro Colombo: “Da questi 10 progetti abbiamo selezionato i 3 migliori per l’articolazione della struttura, la comprensione delle opportunità derivanti dall’attuale scenario economico, ad esempio il Recovery Fund, e gli economics analizzati. Infine, la nostra valutazione si è basata anche sulla presentazione dei progetti in video call e sull’approccio più o meno spigliato che hanno manifestato gli studenti.”
Questo incontro ravvicinato tra Chateau d’Ax e la School of Management è importante sia per l’azienda, perché permette di incontrare i futuri manager con uno strumento di employer branding efficace, sia per gli studenti, perché hanno l’opportunità di confrontarsi con una realtà aziendale in continua evoluzione.
Per i futuri laureati che hanno presentato i 10 progetti più in linea con la strategia aziendale, Chateau d’Ax offrirà dei percorsi di “training&job” per accompagnare gli studenti verso l’acquisizione di conoscenze e lo sviluppo di capacità personali funzionali per l’avvio di una carriera professionale in diversi ambiti aziendali.