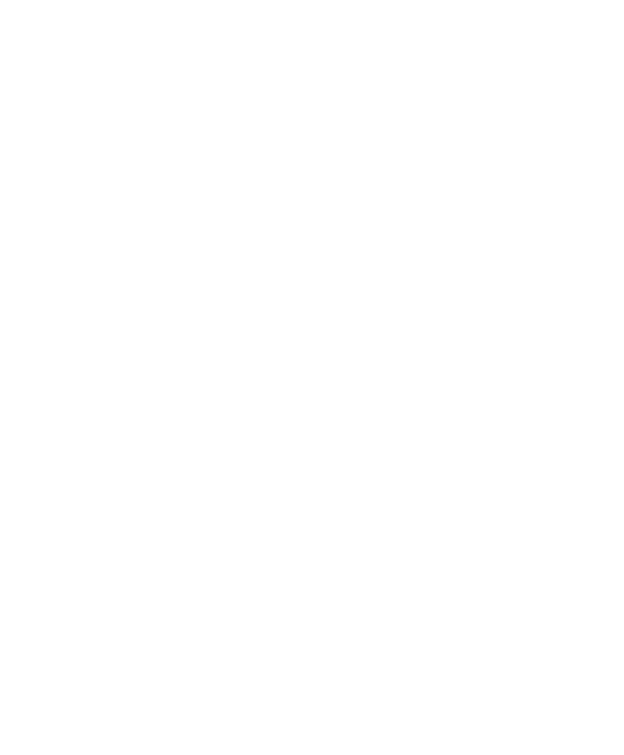Il confronto con i colleghi di master, i due anni di esperimenti e miglioramenti e, soprattutto, una mentalità votata al miglioramento continuo. Martin Leban, alumnus AMIE (ora IMIE), racconta come è nata l’idea di uno shampoo contenuto in biglie biodegradabili.
La formazione nell’azienda di famiglia, il confronto con i colleghi di master provenienti da tutto il mondo e, infine, la nascita di una startup che, ispirandosi a principi di sostenibilità sociale e ambientale, dà vita a un prodotto piccolo, ma dal grande potenziale. È la storia di Martin Leban, giovane imprenditore sloveno e co-fondatore della startup OneTwoThreeZero, nonché alumnus AMIE (ora evolutosi in IMIE, International Master in Innovation and Entrepreneurship) presso il MIP Politecnico di Milano: «Il master mi ha insegnato che di idee, buone e meno buone, ce ne sono tante. A fare la differenza è l’impegno che ci si mette per svilupparle. Ed è proprio così che io e i miei colleghi abbiamo concepito lo shampoo in biglie biodegradabili».
Dall’idea alla sua realizzazione
Leban proviene da una famiglia che possiede una piccola azienda di prodotti per la cura dei capelli. «Un ambiente in cui ho imparato molto, osservando di giorno in giorno», racconta Leban. «Creare cosmetici senza produrre rifiuti è stato uno dei miei obiettivi fin da quando lavoravo nell’azienda di famiglia e vedevo quanta plastica utilizzavamo. Quando ho visto il progetto di shampoo biodegradabili che Renata Alessio, Indira Pambudy e Sarra Elamin avevano iniziato nell’ambito del master AMIE, mi è subito piaciuto e ho chiesto loro di entrare a far parte del team».
Il potenziale ecologico di questa idea è evidente: «L’industria cosmetica utilizza molta plastica per i propri packaging, anche per piccole quantità di prodotto, come capita, ad esempio, con i flaconcini distribuiti negli hotel. Noi siamo partiti da un prodotto concettualmente simile alle capsule di detersivo utilizzate nelle lavastoviglie. In quel caso, però, l’involucro è un materiale plastico. La sfida, per noi, consisteva nel trovare un materiale biodegradabile che al contempo fosse abbastanza resistente da contenere lo shampoo al suo interno». Una sfida raccolta dai suoi due partner e chimici, Anja Pajntar e Uros Novak. «È un processo di ricerca che dura ormai da due anni. La difficoltà è data dalla piccola percentuale di acqua che compone lo shampoo, il 10%, di per sé un grande risparmio rispetto all’80% degli shampoo medi. Potevamo ripiegare su un prodotto senz’acqua, ma l’effetto sui capelli non sarebbe stato lo stesso». La tabella di marcia di OneTwoThreeZero prevedeva una serie di importanti test ad aprile 2020, ma l’attuale situazione sanitaria ha costretto Leban e il suo team a rimandare. «Ormai ci siamo, però. Tant’è che il laboratorio che ci ha ospitati finora non basta più; a breve cominceremo a produrre maggiori quantità del nostro prodotto».
L’importanza di non accontentarsi
Leban non nasconde che l’esperienza al MIP è stata cruciale, per la vita di questa startup. «A cominciare dai miei compagni di corso, di 17 nazionalità differenti. Questa diversità si è rivelata un autentico valore aggiunto, perché mi ha permesso di confrontarmi con punti di vista e culture differenti, che hanno generato un vero flusso creativo. Oggi sfrutto i principi del design thinking appresi grazie al master, che mi ha insegnato anche come dare vita a un team equilibrato, valutando quali possono essere le individualità più strategiche per l’azienda».
Importante anche l’esperienza del project work: «È uno dei motivi per cui ho scelto proprio il MIP. Ho imparato in che cosa consiste il processo di sviluppo, che non è solo una questione di nozioni, ma anche di mentalità. Concentrarsi a fondo su un’idea, per trovarne il vero potenziale e dare vita a una serie di possibilità virtualmente infinite».
Infine, un consiglio a chi sta per iscriversi a un master: «Il modo migliore per viverlo è cercare di arrivare lì con le idee chiare su che cosa si vuole ottenere. E non accontentarsi mai, ma lavorare su sé stessi. Il livello delle lezioni è altissimo, e spinge a puntare ancora più in alto, ad approfondire sempre di più. È questa mentalità che permette di avvicinarsi ai propri obiettivi, sia che si voglia lavorare come imprenditori, sia come consulenti. Le prospettive lavorative legate a questo master sono molteplici».