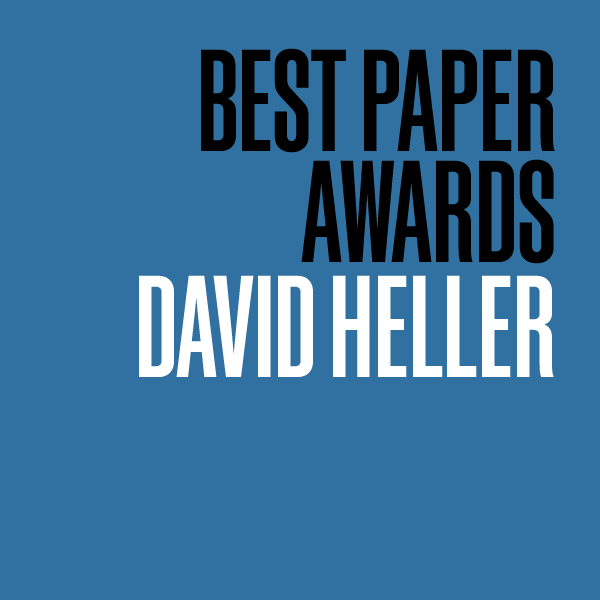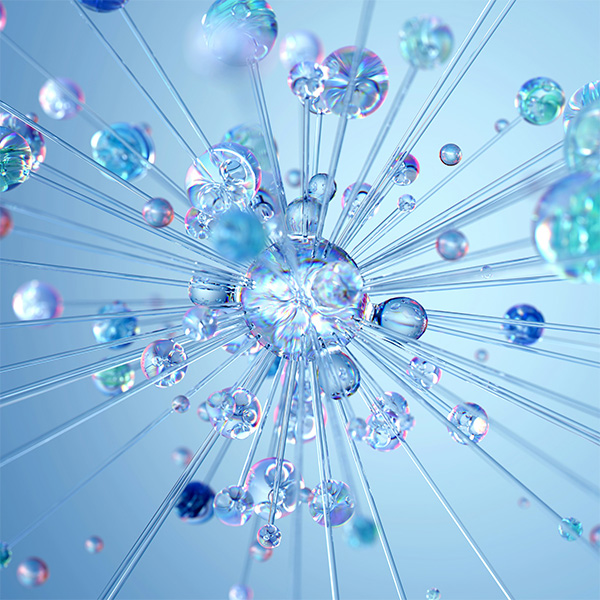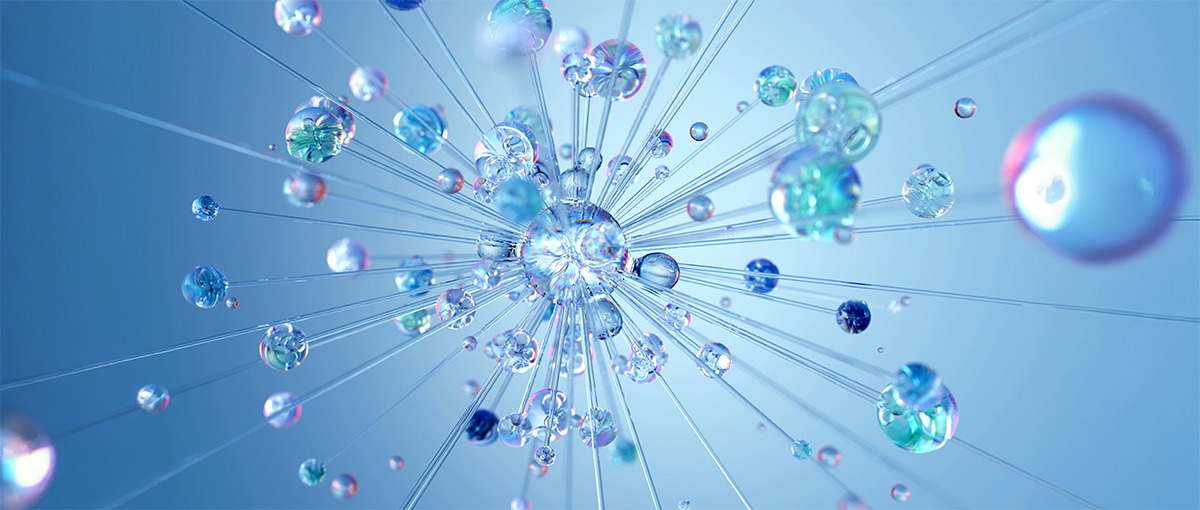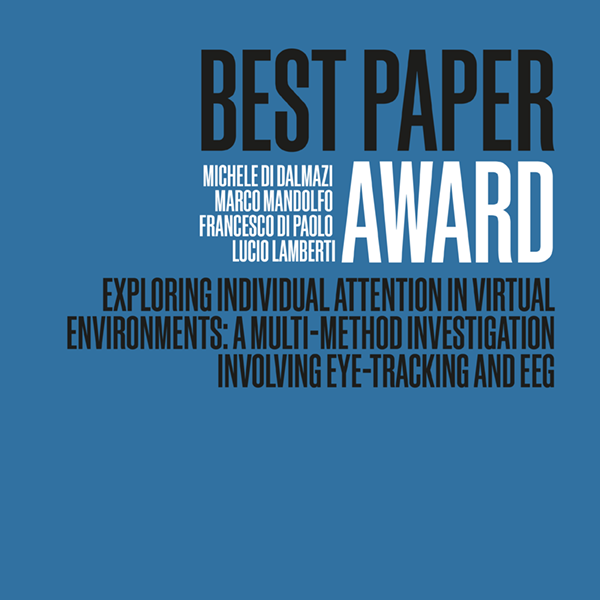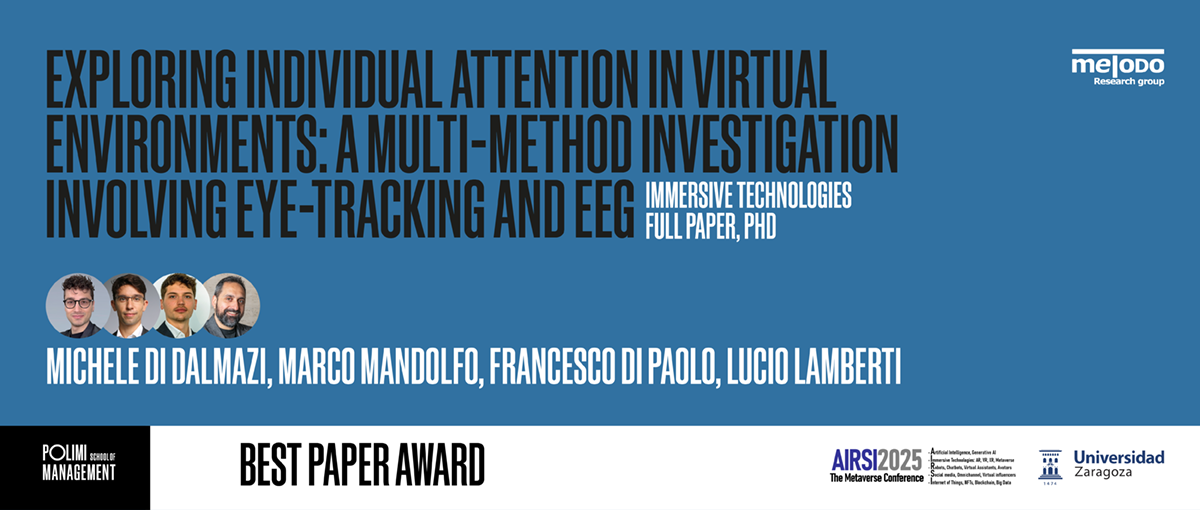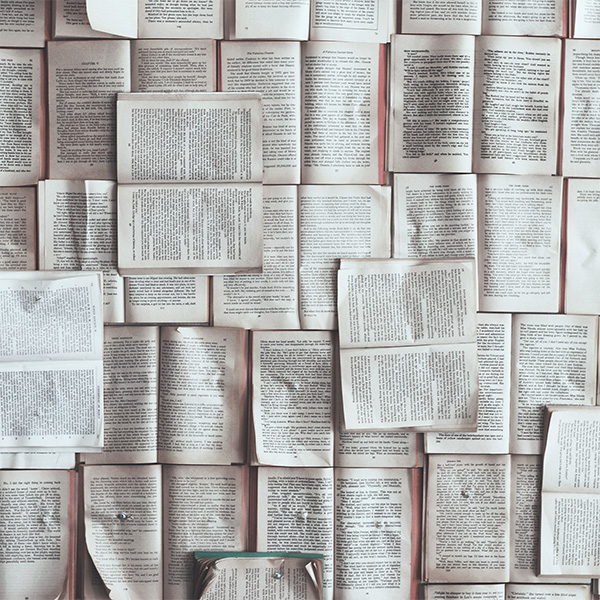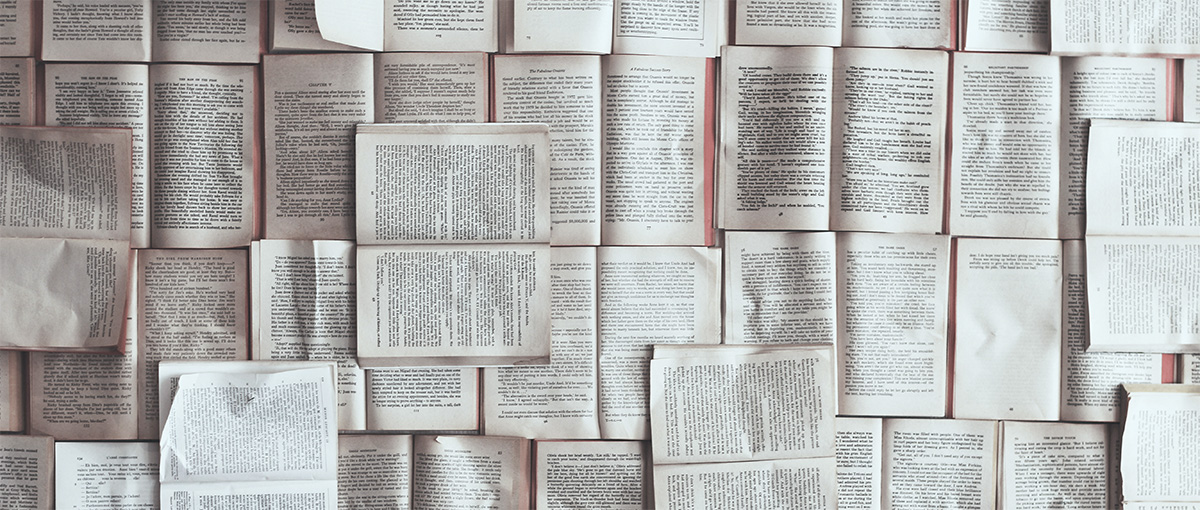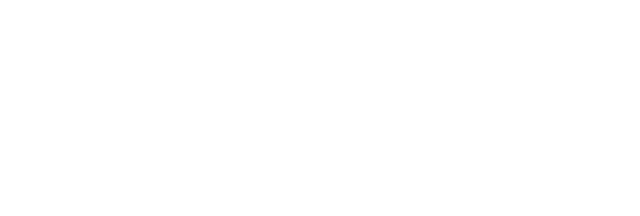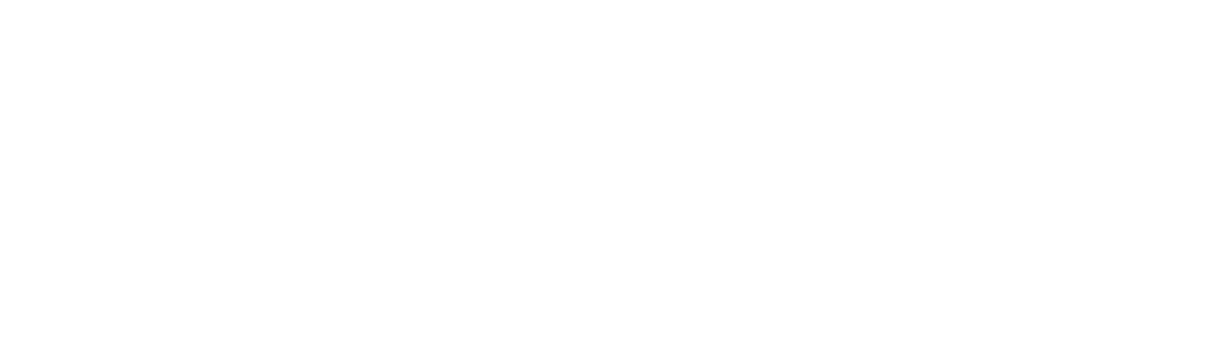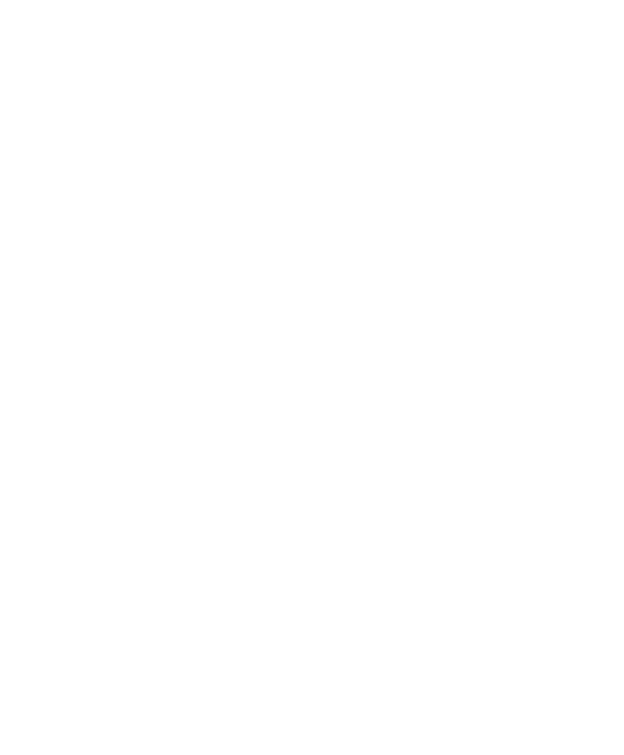David Heller, ricercatore della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano, premiato con il “Best Paper Award” e con l’“European Investment Fund Best Paper Award on Policy Impact” alla ENTFIN Conference 2025 per due studi pionieristici sul ruolo dell’intelligenza artificiale generativa nella produttività aziendale e sull’impatto delle politiche pubbliche sull’internazionalizzazione delle startup.
In occasione della 9ª edizione dell’Annual Meeting of the Entrepreneurial Finance Association (ENTFIN), tenutasi dal 2 al 4 luglio 2025 presso l’Erasmus University di Rotterdam, David Heller, ricercatore della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano, ha ricevuto due importanti riconoscimenti: il Best Paper Award e l’European Investment Fund Best Paper Award on Policy Impact.
La conferenza ENTFIN è un evento internazionale di riferimento per studiosi e professionisti interessati alla finanza imprenditoriale, che coinvolge esperti di management, finanza ed economia. L’obiettivo di ENTFIN è favorire la collaborazione tra accademici e practitioner del settore, stimolando la realizzazione di ricerche di alta qualità in questo ambito.
Nel corso dell’edizione 2025, David Heller è stato premiato per due studi che esplorano rispettivamente gli effetti dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) sulla produttività delle imprese e l’impatto dei programmi pubblici di accelerazione sull’internazionalizzazione delle startup.
Il Best Paper Award è stato assegnato allo studio “Generative AI and Firm-level Productivity: Evidence from Startup Funding Dynamics”, di cui è co-autore Dominik Asam (è possibile accedere al paper a questo link). La ricerca fornisce una delle prime evidenze su larga scala dell’impatto della GenAI sulla produttività aziendale. Analizzando il lancio di GitHub Copilot nel 2021 come esperimento naturale, lo studio mostra che le startup attive nello sviluppo software ottengono finanziamenti iniziali in modo significativamente più rapido (+19%) e con un numero inferiore di sviluppatori impiegati (-20%). Tuttavia, questi effetti si concentrano nelle startup guidate da fondatori con elevata esperienza, evidenziando come i benefici della GenAI dipendano fortemente dalla presenza di capitale umano qualificato.
L’European Investment Fund Best Paper Award on Policy Impact è stato conferito a David Heller per il paper “Learning from Abroad? Startup Accelerators and International Market Entry” (co-autori Daehyun Kim e Dietmar Harhoff). La ricerca analizza le strategie di internazionalizzazione delle startup, una leva fondamentale per molte realtà imprenditoriali, focalizzandosi sul German Accelerator (GA), un programma finanziato dal governo tedesco per supportare l’ingresso delle startup nei mercati esteri. Utilizzando un dataset unico che unisce dati proprietari sulle candidature al programma con informazioni dettagliate su startup, fondatori e investimenti, lo studio mostra che le startup partecipanti hanno ottenuto finanziamenti più consistenti e aumentato il numero di dipendenti nei Paesi target del programma. Tuttavia, gli effetti sono meno marcati per le startup che hanno preso parte ai programmi online introdotti in risposta alla pandemia di COVID-19, mentre risultano più significativi per quelle con fondatori che avevano una limitata esperienza internazionale pregressa. In questo modo, la ricerca contribuisce ad approfondire la comprensione del potenziale e dei limiti dei programmi di accelerazione nel supportare l’internazionalizzazione delle startup.
I premi ricevuti confermano il valore scientifico e l’impatto concreto delle ricerche svolte e ribadiscono il contributo della POLIMI School of Management del Politecnico di Milano allo sviluppo di nuove conoscenze nei campi della finanza imprenditoriale, delle politiche per l’innovazione e del potenziale trasformativo delle tecnologie emergenti.