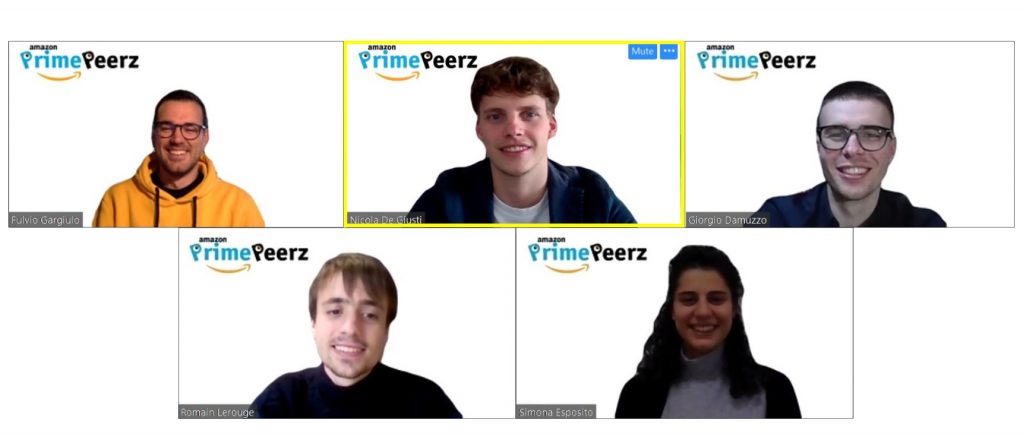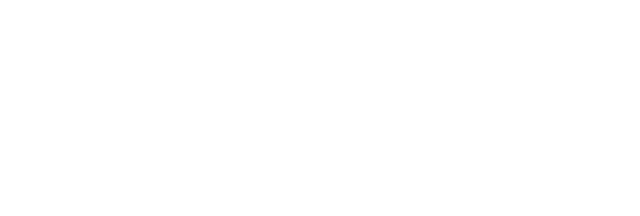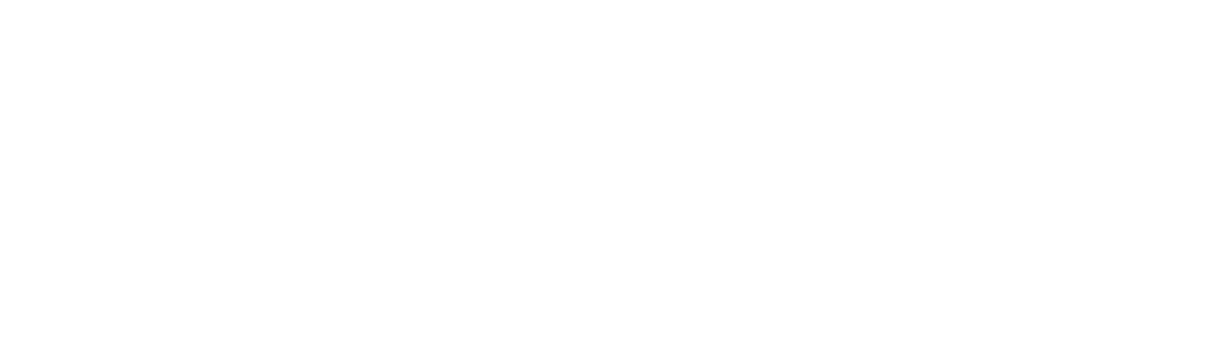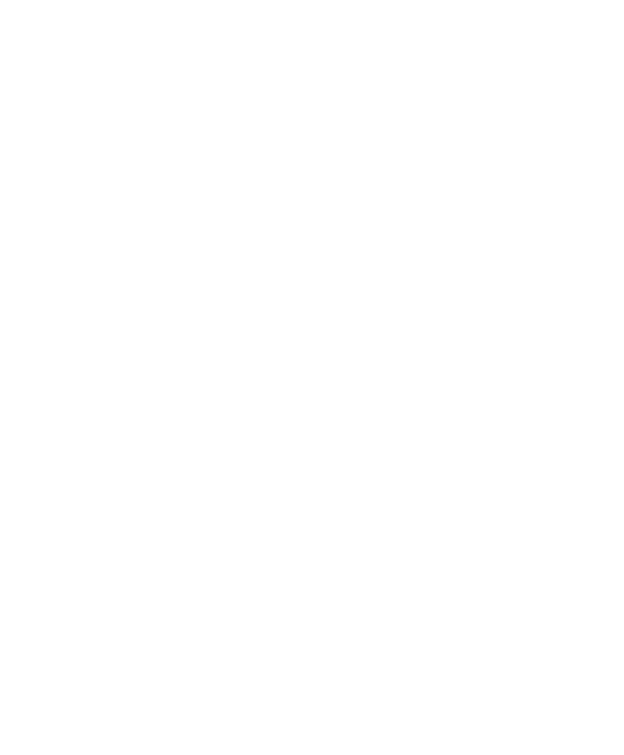L’emergenza legata alla pandemia del virus Covid-19 sta avendo impatti significativi anche sull’industria del lusso: i più importanti player del settore hanno già iniziato a rivedere le loro strategie, alla luce del fatto che le minacce legate a cambiamenti strutturali nel mercato potrebbero per alcuni trasformarsi in opportunità.
Alessandro Brun, Professore di Quality Management, Direttore del Global Executive Master of Luxury Management e fondatore Sustainable Luxury Academy
Co-autrice Cecilia Castelli, Extended Faculty MIP Graduate School of Business
School of Management Politecnico di Milano
Nella prima parte di questo articolo (L’impatto del Covid-19 sulle abitudini di acquisto dei clienti del lusso) abbiamo mostrato i principali cambiamenti che ci attendiamo nel settore. I manager dell’industria del lusso non stanno certo fermi a guardare.
Mentre le fabbriche sono state convertite a – e dal New York Post [i] al the Guardian [j] arrivano i plausi ad Armani che realizza camici, Prada e Gucci mascherine, Bulgari si focalizza sull’hand-sanitizer, e anche la tecnologia di Ferrari viene messa al servizio dell’emergenza per realizzare Respiratori – nelle stanze dei bottoni si pensa già alle strategie per il dopo-Covid.
Le reazioni dei brand
Come si stanno muovendo i brand del lusso oggi? Ce ne parlano Lorenzo Bertelli, Head of Marketing and Head of CSR di Prada, Giorgio Ravasio, Country Manager Vivienne Westwood Italia, ed Eugenia Di Muzio, Worldwide Commercial Manager Rene Caovilla.
Per Bertelli: “Riteniamo che verrà assegnata più importanza al valore intrinseco del prodotto (ad esempio per l’eccellenza delle lavorazioni, dei materiali), ma non a scapito del valore del brand, non è un trade-off. I valori rappresentati dal brand saranno ancora più importanti nel momento in cui saranno percepiti come credibili. Il consumatore chiederà maggiore trasparenza e l’attenzione ai temi della sostenibilità diventerà ancora più centrale, non solo rispetto al prodotto ma anche con riferimento alla mission aziendale. Ipotizziamo una rinnovata scoperta delle relazioni interpersonali nei comportamenti d’acquisto, con rapporti più diretti e umani. Attendiamo una maggiore elasticità della domanda al prezzo anche nelle fasce premium quale conseguenza di un atteggiamento d’acquisto più consapevole e orientato a prediligere prodotti con un riconoscibile valore intrinseco”.
E’ simile la percezione di Ravasio: “Gli acquisti saranno più consapevoli per due motivi principali: la diminuzione dei redditi e la riflessione generata da una situazione nuova che ha reso l’umanità più fragile e meno certa. Sopravviveranno i brand che hanno una forte identità, che lavorano con bene in mente la qualità del prodotto, l’affidabilità del servizio, la garanzia di continuità e che rappresentino dei forti valori in tema etico, ambientale e sociale. Chi non sarà in grado di dare questi messaggi non sopravviverà a lungo e il Covid-19 non ha fatto altro che accelerare un processo di trasformazione già in atto”.
Per Vivienne Westwood l’on-line è “esploso letteralmente. I negozi fisici saranno di meno ma saranno tutti rinnovati per dare la migliore presenza e immagine possibile ai brand. Diventeranno ambasciatori dei valori del brand e consulenti del cliente per valorizzare la propria immagine. Chi sarà semplicemente alternativo all’on-line senza offrire nulla di più non avrà futuro. La tendenza che sarà accelerata sarà legata alla “maisonizzazione” della filiera distributiva. Come già successo per la produzione, ci si avvierà verso la gestione diretta della catena retail. Sarà un processo graduale ma credo inesorabile” conclude Ravasio.
Anche la risposta di Prada è all’insegna della continuità, in quanto – prosegue Bertelli “Il retail non sarà accantonato e rimarrà centrale in una strategia omnichannel dove conterà ancora di più l’integrazione tra i vari canali diretti, retail ed e-commerce diretto, e indiretti, market place e wholesale. Il consumatore premium, ma anche i marchi di questa fascia, vogliono sempre meno intermediari, sia nel fisico che nel digitale; si tratta [per Prada] di un trend già in essere che sta subendo un’accelerazione a seguito di questa crisi”.
Per Caovilla, “In un’integrata ottica multichannel, non avremo più assortimenti e stock segregati per punto vendita o città, ma un unico grande stock, orientato all’unico risultato che conta: la vendita del prodotto al cliente a prescindere dalla location in cui essa avviene.
Ciò richiederà sforzi di ammodernamento di sistemi gestionali e operativi nonché di flussi logistici e di un rodato meccanismo di consegne, spedizioni e resi. Anche il mondo dei negozi retail cambierà sia in ottica di assortimento delle collezioni, sia in ottica di esperienza di vendita. Le nuove norme improntate al rispetto della social distance, renderanno necessario ridisegnare gli spazi dei punti vendita, in chiave di maggiore separazione e distanza. Tuttavia, squisitamente nell’ambito del lusso questa nuova esperienza di vendita, lascia intravedere anche un’opportunità di ridisegnare per il cliente una esperienza di ulteriore unicità ed esclusività. Una esperienza di vendita one-to-one simile agli appuntamenti negli atelier di Haute Couture. Ancora una volta una potenziale opportunità derivata da una nuova restrizione imposta”.
Ma ciascun canale dovrà trovare il modo di raggiungere il break-even, come spiega Di Muzio: “Un grosso interrogativo, per le aziende con negozi retail, sarà come sostenere finanziariamente la rete di punti vendita e flagship stores con elevati costi di gestione, a fronte di una vendita che avviene sempre di più online. Il retail rimarrà sempre e comunque la massima espressione dei valori visibili del brand e dovrà fare lo sforzo di cambiare, di rendersi meno ovvio e di provare al consumatore l’effettivo vantaggio di una store experience. Che sia con collezioni dedicate, con momenti di puro intrattenimento tramite eventi dedicati o inviti a esperienze uniche per i clienti più loyal, o offrendo ai clienti servizi in più – dal made to order alla consulenza di immagine, al supporto in ottica cross-selling e total look. Certamente contare solo sulla disponibilità dell’assortimento in attesa che il cliente varchi l’ingresso non sarà più percorribile”.
Di Muzio racconta come stanno gestendo l’emergenza nel breve in Rene Caovilla, per tenere in vita le piccole realtà locali: “Certamente pur non esistendo la ricetta perfetta, un buon mix di interventi mirati alla riduzione dei costi del personale in un’ottica di maggiore efficienza, uniti agli aiuti stanziati dai vari governi, insieme ad una stretta collaborazione tra aziende della filiera, sono gli ingredienti primari. In un momento in cui il flusso di cash-in è ridotto o inesistente, occorre collaborare in maniera organica e organizzata con tutti i fornitori e partner della filiera, cercando soluzioni. Tempi di pagamento più lenti, ma costanti; scontistiche più favorevoli a fronte di pagamenti a vista; piccoli ordini scadenzati nel tempo anziché un unico grosso ordine. Tutto deve essere ribilanciato con un’ottica di “contagocce”, il sistema non deve e non può entrare in stasi: sarebbe la fine accertata per molti piccoli fornitori e vari distretti di eccellenza delle nostre regioni italiane”.
In attesa delle decisioni dei Governi, Prada ha già pronto un piano per la riapertura delle fabbriche che consentirà agli operatori di poter lavorare nel rispetto degli standard di sicurezza sanitaria più elevati (distanza, dispositivi di protezione, controlli, sanificazione, turni, etc..).
Tutti i brand intervistati hanno confermato che l’arrivo della collezione Autunno Inverno 20-21 verrà leggermente posticipato.
Una mobilità ancora limitata potrebbe influenzare le campagne vendita per il mercato wholesale, per questo Ravasio ci parla di come stiano lavorando “alla creazione di showroom digitali che consentiranno di evitare viaggi e trasferte a buyer di tutto il mondo”. In quest’ottica le settimane della moda cambierebbero la loro vocazione, continua Ravasio “Le sfilate manifesteranno la vera realtà di show per il pubblico. Valori ma non prodotti – o prodotti con valore. Non più funzionali al business”.
“Con i buyer impossibilitati a viaggiare da tutto il mondo per recarsi negli showroom per gli ordini di collezione, l’intero sistema subirà una stasi fisica a favore di una maggiore vivacità virtuale: appuntamenti su showroom e piattaforme virtuali per conoscere le collezioni e finalizzare i propri ordini. Incrementando la domanda per la produzione di contenuti digitali e piattaforme di condivisione in grado di restituire in maniera sempre più chiara la realtà dei prodotti”, prosegue Di Muzio, “Sarà una fase di sperimentazione in cui capiremo cosa funziona e cosa no… cosa è possibile fare a distanza e cosa non è possibile. Il lusso segue delle logiche ben precise che la contingenza sta modificando, ma che non riuscirà a eliminare o sradicare. I prodotti del lusso che presentano prezzi elevati, richiedono in fase di selezione ed acquisto dei buyer (ma anche dei clienti) una amplificata attenzione alla qualità e ad ogni singolo dettaglio. E già nella passata FW20 si sono evidenziati chiari limiti e perplessità sulla fattibilità degli ordini a distanza. Anche e soprattutto quando i volumi di acquisto sono importanti. Più facile quando il prodotto è già noto, ma difficilissimo quando il prodotto non è conosciuto o nelle fasi di start-up o negoziazione di nuove opportunità di business”.
Quali suggerimenti quindi dare ai brand del lusso per la ripresa?
I brand dovrebbero innanzitutto riprendere piena coscienza del vero significato del lusso: tornare alle origini del savoir faire artigianale, del bello fatto bene, prendersi una pausa dai ritmi incessanti del fast fashion, o quantomeno rallentare – e tornare a fare sentire i propri clienti “esclusivi”. Come sottolineato da tutti gli intervistati, la disintermediazione dei canali di vendita porterà ad un rapporto più “intimo” con i clienti.
Per non risultare fuori luogo, in un clima di morigeratezza sociale, l’approccio al marketing dovrà essere da un lato più discreto e al tempo stesso responsabile. Una parte significativa del budget per comunicazione “above the line” potrebbe essere utilizzato per “cause related marketing” o trasformato in budget per comunicazione “below the line”.
Per evitare il rischio di financial distress nel breve periodo, sarà fondamentale iniziare la ripresa da quei canali, mercati, e categorie merceologiche che ripartiranno più velocemente: online e discount i canali su cui scommettere; per le economie mature, e per la Cina, cercare di incontrare i clienti localmente (anche se i Cinesi in viaggio in Europa sono più incentivati a fare shopping di lusso Tax Free); e, in termini di categorie di prodotto, beauty, fine food and wine, art de la table, personal mobility, articoli evergreen e no logo e, ovviamente, esperienze. Ma per sopravvivere nel lungo periodo i brand dovranno completare la transizione da player brick and mortar a player omnipresenti.
Infine per superare la crisi le aziende dovranno fare leva sulle tecnologie digitali, con impatto sia sulla semplificazione dei processi che sull’organizzazione del lavoro, e attivare meccanismi di collaborazione e condivisione con i vari partner della filiera, che vadano dai dati alle strategie, per essere più forti assieme.
Già c’è chi parla di “selezione della specie”. Probabilmente, come dice Lorenzo Bertelli, “Attendiamo, verosimilmente, un ritorno alla normalità pre-pandemia solo con l’arrivo del vaccino, quando le persone potranno tornare a circolare liberamente. Per noi quest’emergenza richiede sicuramente degli adattamenti, ma non mette in discussione i fondamentali del settore del lusso, né ci richiede di modificare il nostro modello di business.”
Presenza online e strategia digitale consolidate; collezioni fluide senza una vera e propria dicotomia Primavera-Estate e Autunno-Inverno; focus sul valore intrinseco del prodotto e investimenti sulla sostenibilità a livello di intera filiera: alcuni brand si sono presentati a inizio 2020 meglio preparati di altri per affrontare l’inaspettata emergenza Covid. Per tutti gli altri, la capacità di adattamento si rivelerà, oggi più che mai, indispensabile per superare la crisi.
______________________________
[i] A. Moussavian. Luxe Labels Gucci, Armani, Bulgari make protective gear to fight coronavirus. New York Post, 26 Marzo 2020 https://nypost.com/2020/03/26/luxe-labels-gucci-armani-bulgari-make-protective-gear-to-fight-coronavirus/
[j] E. V. Bramley. Prada the latest fashion brand to make medical face masks. The Guardian, 24 Marzo 2020 https://www.theguardian.com/fashion/2020/mar/24/prada-the-latest-fashion-brand-to-make-medical-face-masks