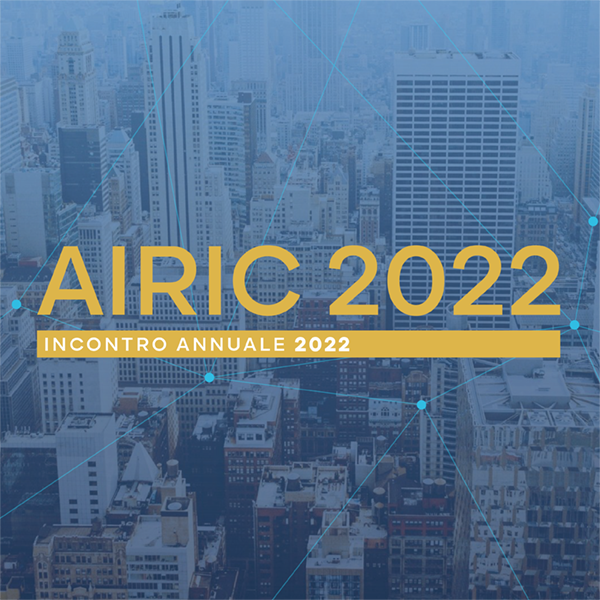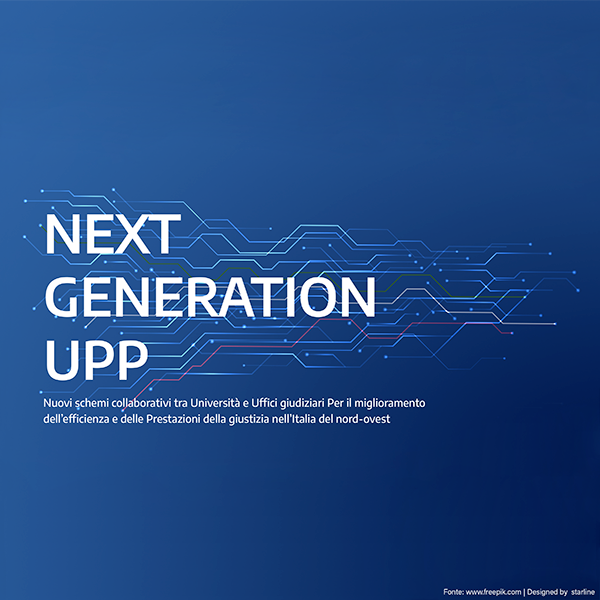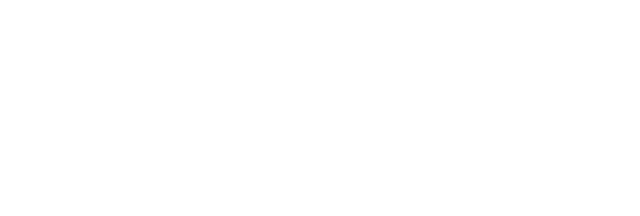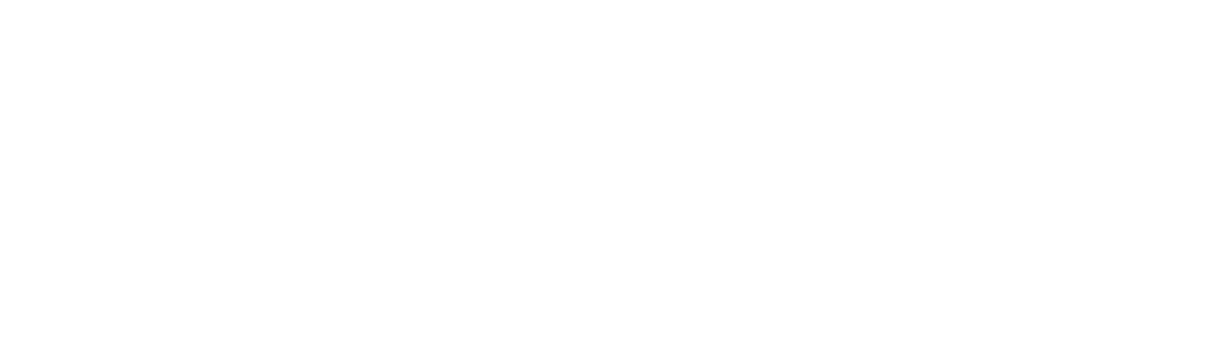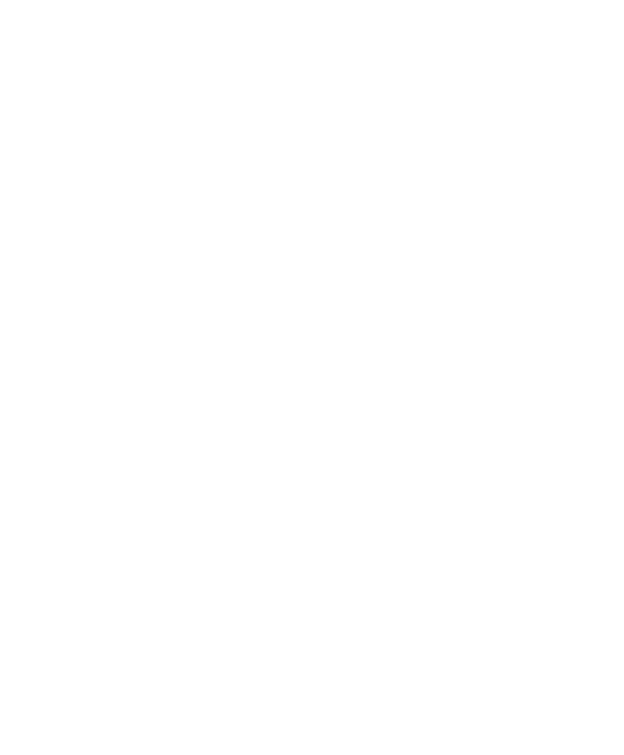Milano è rinomata a livello globale per la sua industria del lusso, che comprende moda, design e tutti i settori correlati come la bellezza e la gioielleria. Queste industrie stanno attualmente subendo una profonda trasformazione, fondendo i loro elevati standard e caratteristiche eccezionali con la crescente domanda globale dei consumatori per prodotti e pratiche sostenibili.
Per gestire la complessità di questa transizione, MUSA Spoke 5, un progetto finanziato dal PNRR mira a progettare e diffondere best practice fornendo supporto per favorire l’innovazione sostenibile a partire dalla municipalità di Milano.
L’evento “Dove il lusso incontra la sostenibilità” tenutosi il 16 maggio 2024 al Politecnico di Milano ha segnato un passo significativo in questo percorso, creando una comunità di aziende interessate ad attivare un processo di collaborazione, attivando una dialogo costruttivo verso nuove pratiche grazie ad interventi di ospiti rinomati.
Gli ospiti hanno arricchito la conversazione fornendo approfondimenti sulle principali innovazioni nei settori correlati, a partire dal ruolo che le tecnologie digitali possono offrire.
Paolo Stella, influencer e direttore creativo del progetto @suonarestella ha condiviso il valore di riflettere criticamente sul ruolo che gli oggetti intorno a noi possono svolgere per nutrire l’innovazione.
Durante l’incontro ha presentato il progetto Suonare Stella come un’opportunità per sfruttare i social media per generare consapevolezza su campi come il design, tradizionalmente lontani dalla coscienza mainstream, introducendo nuovi concetti e tendenze a un pubblico più ampio.
Per rafforzare il ruolo della digitalizzazione, Valentina Pontiggia, Direttrice dell’Osservatorio eCommerce B2c e Innovazione Digitale nel Retail degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano ha sottolineato l’importanza di integrare le tecnologie digitali per supportare l’innovazione sostenibile.
Attraverso la ricerca degli osservatori, ha evidenziato come l’analisi dei dati e la tracciabilità dei prodotti stiano diventando cruciali per promuovere un’innovazione equa e affidabile. Questa integrazione non solo migliora la sostenibilità ambientale, ma rafforza anche la responsabilità sociale.
Carlo Salvato, Professore di Strategia aziendale all’Università Bocconi di Milano, ha contribuito al dialogo discutendo di come le piccole e medie imprese (PMI) possano raggiungere l’innovazione sostenibile sfruttando le loro capacità uniche di flessibilità e connessione locale. Condividendo i dati della ricerca dell’Osservatorio AUB, ha sottolineato l’importanza della diversità in termini di età e genere come catalizzatori per un’innovazione accresciuta e prestazioni superiori, mettendo in luce il potenziale dei team diversificati per guidare il progresso nella sostenibilità.
Edoardo Iannuzzi, fondatore della startup ACBC, ha sottolineato, riecheggiando i valori fondamentali della comunità MUSA, che la trasformazione sostenibile va oltre i cambiamenti materiali. Comporta una rimodellazione fondamentale delle collaborazioni tra le parti interessate e la promozione dell’innovazione sistemica. Con la sua azienda, Iannuzzi ha evidenziato la necessità di creare un sistema globale e interconnesso in cui vari attori cooperano per ridurre il consumo di materiali e promuovere pratiche sostenibili.
L’essenza di questo evento risiedeva nella sessione di matchmaking, instaurando i primi legami all’interno della comunità di aziende nei settori della moda, del design, della bellezza e del lusso. Questa comunità mira a riunire aziende già impegnate nella sostenibilità con quelle che aspirano a transitare verso pratiche più sostenibili, favorendo la collaborazione per sostenersi reciprocamente nel plasmare un futuro sostenibile. La diversità dei background dei partecipanti rafforza le opportunità di innovazione che queste interazioni consentono, diventando un’opportunità fondamentale per interagire con aziende che sono tipicamente difficili da raggiungere.
L’obiettivo finale della comunità MUSA è diventare un hub centrale per promuovere pratiche innovative e supportare sia le PMI che le aziende affermate nel loro percorso verso l’innovazione sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo, MUSA Spoke 5 attiverà nel prossimo periodo una piattaforma digitale per nutrire e sostenere nel tempo questa comunità, aprendo la strada a un futuro più sostenibile nell’industria del lusso di Milano.