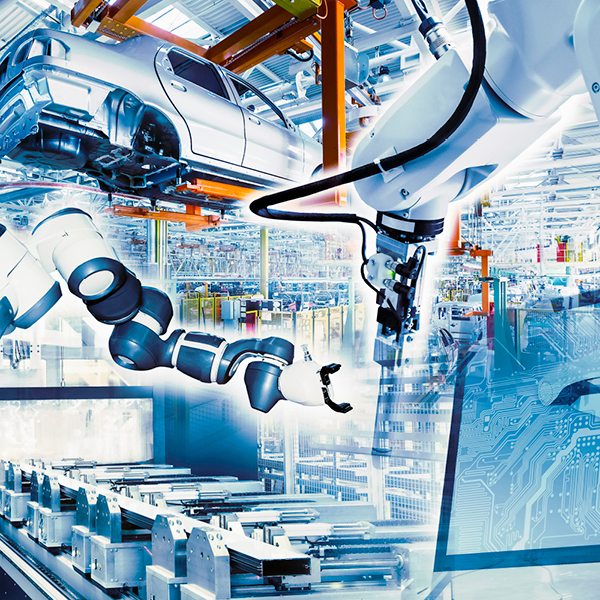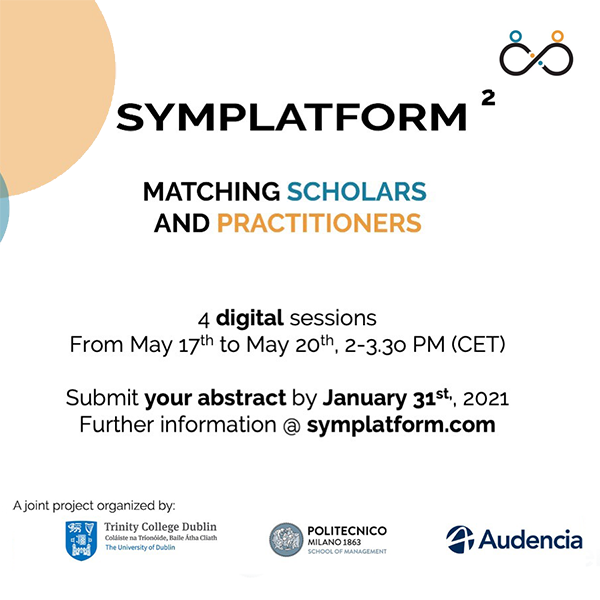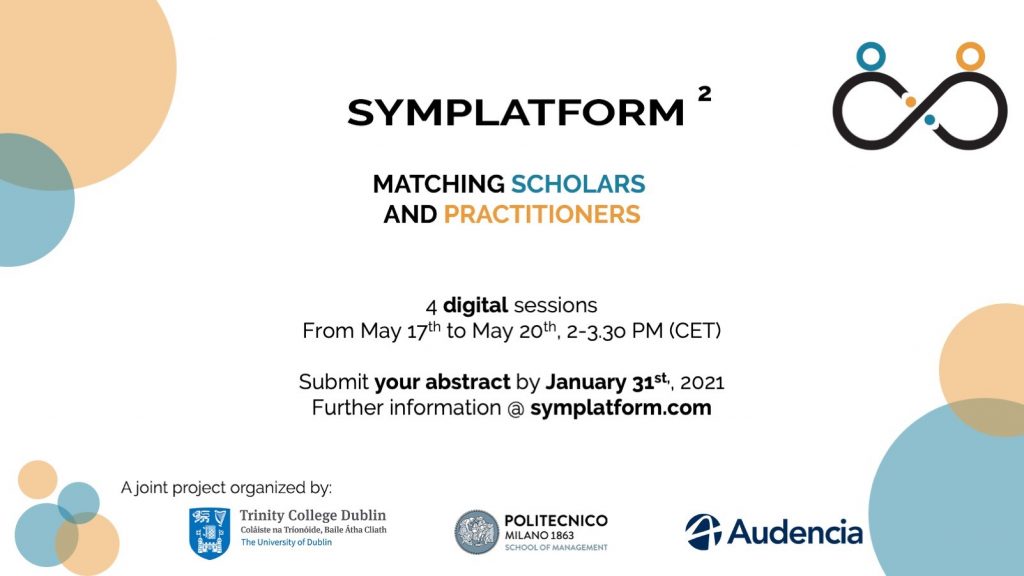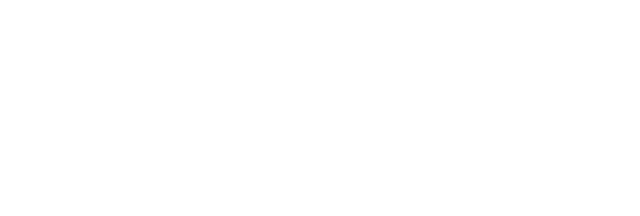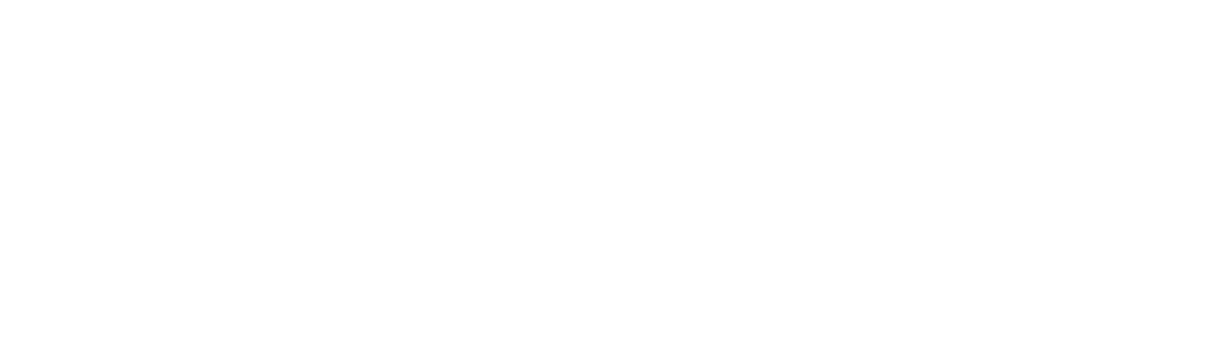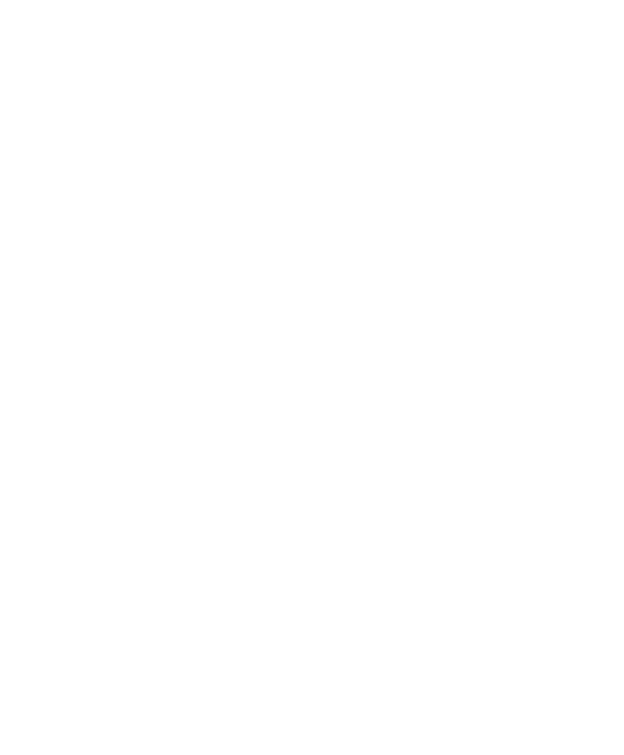Il premio è dedicato alle azioni per proteggere l’ambiente e il progetto di Milano contro lo spreco alimentare ha vinto un milione di sterline e il supporto della Royal Foundation per i prossimi anni
Milano, 18 ottobre 2021 – Nella notte di domenica 17 ottobre 2021 il Principe William ha annunciato che la Città di Milano, con il progetto della Food policy degli Hub di quartiere contro lo spreco alimentare, è vincitrice della prima edizione del prestigioso premio internazionale Earthshot Prize sulle migliori soluzioni per proteggere l’ambiente.
Un mese fa era arrivato l’annuncio di essere tra i 15 finalisti nella sezione “un mondo senza sprechi” e ieri in collegamento su BBC e Discovery Channel il Principe William ha svelato i vincitori, dopo la valutazione di un comitato di esperti internazionale che ha scelto Milano tra 750 iniziative candidate da tutto il mondo.
Insieme a Milano nelle altre quattro categorie del premio sono risultati vincitori: dalla Repubblica della Costa Rica per la protezione delle foreste, dall’India per la riduzione delle emissioni dei fumi in aria, da Berlino per lo sviluppo di tecnologie ad idrogeno per la produzione energetica e dalle Bahamas per la difesa delle barriere coralline.
A Milano la BBC ha preparato un collegamento con Londra da una terrazza con vista Duomo, al quale ha preso parte la Vicesindaco Anna Scavuzzo, con rappresentanti di tutti i partner che rendono vivo questo progetto.
Il premio di un milione di sterline verrà utilizzato per potenziare sempre più questi Hub, aprirne di nuovi, garantendone la sostenibilità sul lungo periodo e replicare questa virtuosa buona pratica nella rete delle città che lavorano con Milano sulle food policy, partendo dalla rete delle città di C40 e del Milan Urban Food Policy Pact.
Vincere l’Earthshot prize è il riconoscimento di un grande lavoro di squadra che ha coinvolto l’intera città: grazie al Comune e a tante realtà del Terzo settore, delle università, della Grande Distribuzione e della filantropia operative sul territorio, oggi Milano ha 3 Hub di quartiere a Isola (2019), Lambrate (2020) e al Gallaratese (2021).
Il progetto è nato nel 2017 da un’alleanza tra Comune di Milano, Politecnico di Milano con il gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Gestionale Food Sustainability Lab di cui fa parte l’Osservatorio Food Sustainability, Assolombarda, Fondazione Cariplo e il Programma QuBì.
La realizzazione del primo Hub ha poi coinvolto Banco alimentare della Lombardia e ha permesso di salvare oltre 10 tonnellate di cibo al mese, assicurando in un anno un flusso di 260.000 pasti equivalenti, che hanno raggiunto 3.800 persone, grazie al contributo di 20 supermercati, 4 mense aziendali e 24 enti del Terzo settore.
In particolare, il ruolo dell’Osservatorio Food Sustainability, è stato quello di elaborare lo studio di fattibilità della rete e di monitorare l’operatività degli hub e gli impatti generati dal progetto, che ha permesso di costruire un modello logistico estendibile e replicabile in altri quartieri della città.
A seguire, è stato infatti avviato l’Hub di Lambrate, subito dopo il primo lockdown nella primavera 2020, gestito sempre da Banco alimentare della Lombardia in uno spazio messo a disposizione da AVIS Milano e con il contributo di BCC Milano. Il terzo Hub, al Gallaratese, è gestito da Terre des Hommes con il contributo di Fondazione Milan.
Il prossimo, in fase di progettazione, sarà l’Hub di quartiere di Corvetto, con la gestione del Banco Alimentare della Lombardia e il contributo della Fondazione SNAM; mentre per aprirne un quinto il Comune di Milano ha recentemente avviato il tavolo di coprogettazione per l’Hub del Centro con l’Associazione IBVA e con il contributo di BCC Milano.
Il team del Dipartimento di Ingegneria Gestionale:
Alessandro Perego, Marco Melacini, Giulia Bartezzaghi, Annalaura Silvestro e Andrea Rizzuni del gruppo di ricerca Food Sustainability.
Partner coinvolti:
Il progetto coinvolge importanti insegne della grande distribuzione tra cui Lidl Italia, Esselunga, Carrefour, NaturaSi, Erbert, Coop Lombardia, Il Gigante, Bennet, Penny Market con il supporto di Number1 Logistics Group che ha fornito i furgoni per gli Hub di Isola e Lambrate. Sono state coinvolte inoltre le mense di Pirelli, Siemens, Deutsche Bank e Maire Tecnimont coordinate dal Gruppo Pellegrini per l’Hub Isola.
Con Fondazione Cariplo e SogeMi il Comune di Milano ha inoltre lanciato l’iniziativa Foody zero sprechi per replicare il modello degli hub anche all’Ortomercato e recuperare il cibo fresco insieme a Banco alimentare della Lombardia, Recup, Croce rossa sud milanese, Università degli studi di Milano e molti altri partner in supporto..