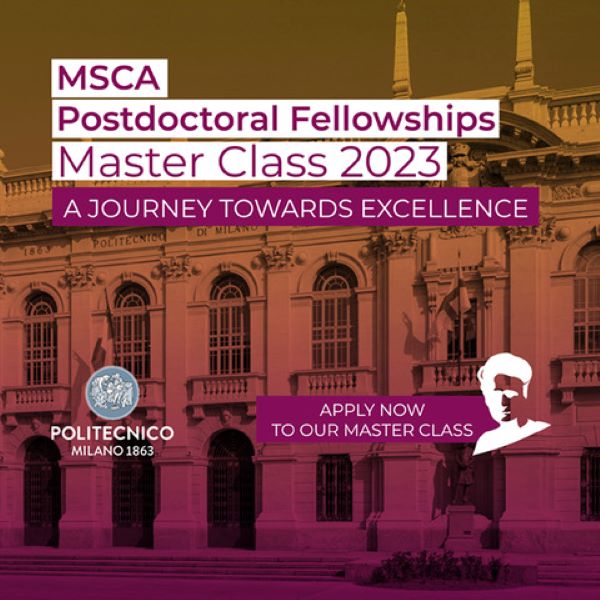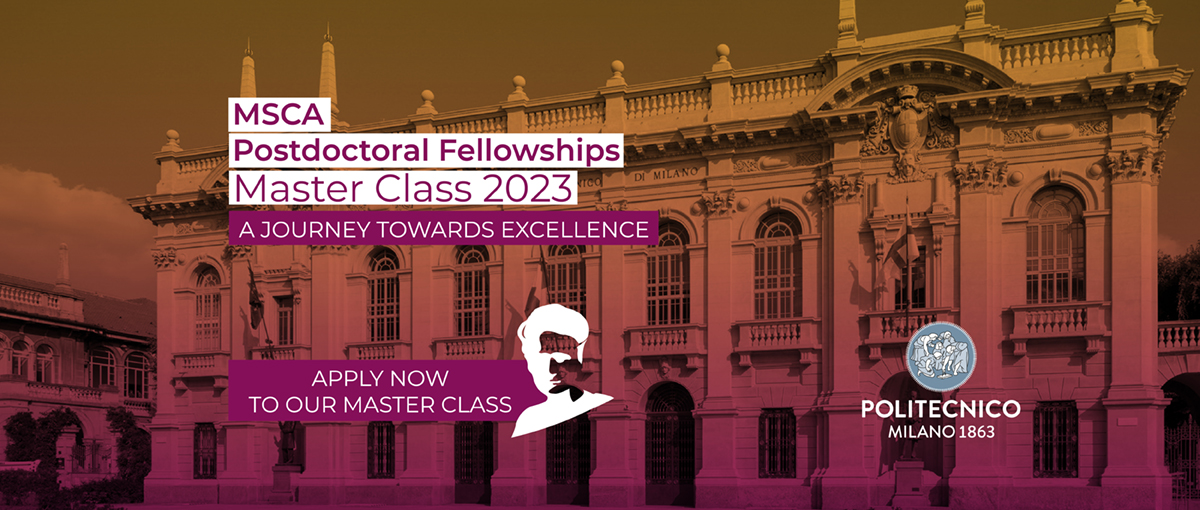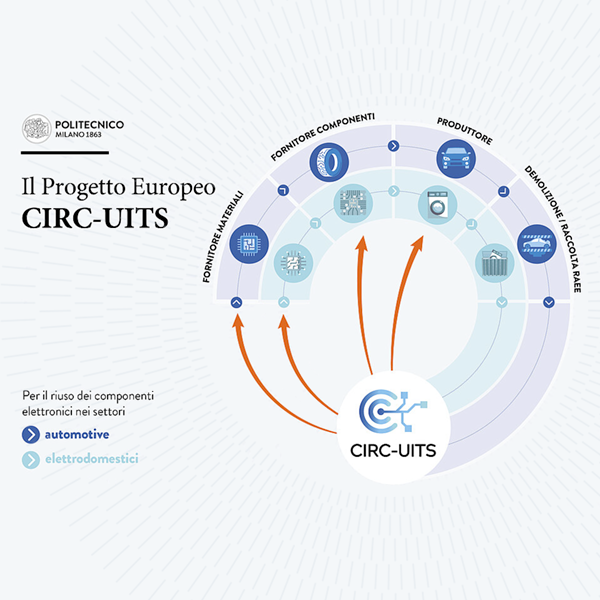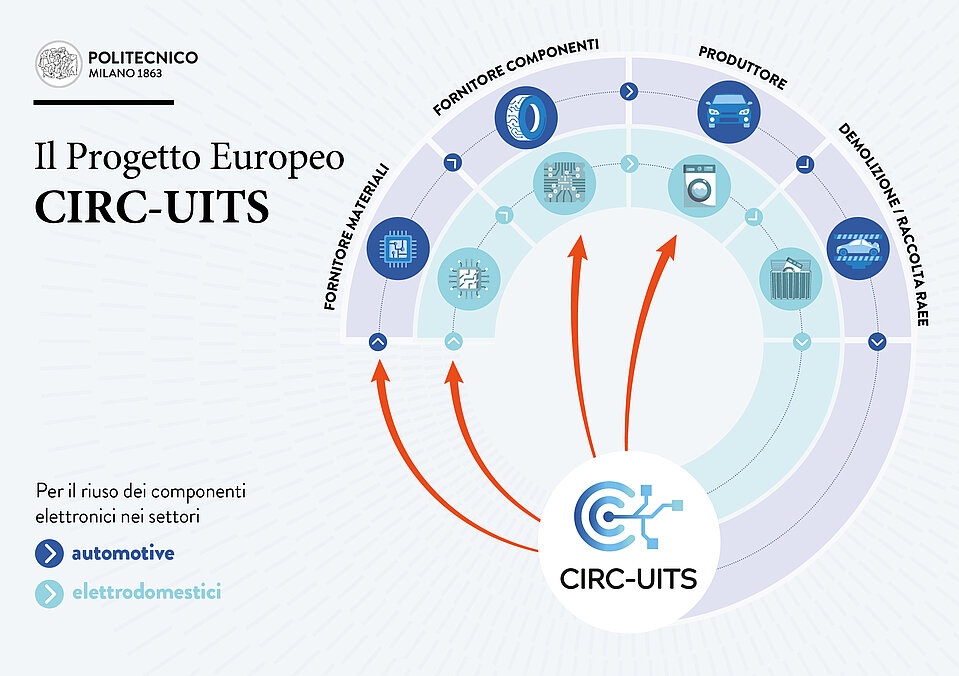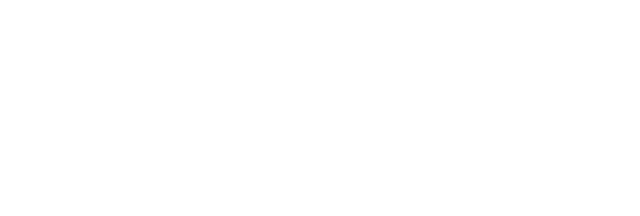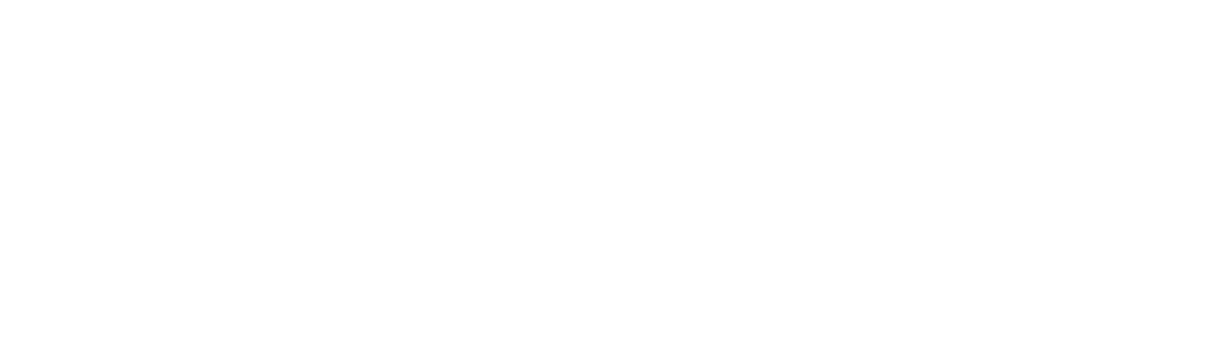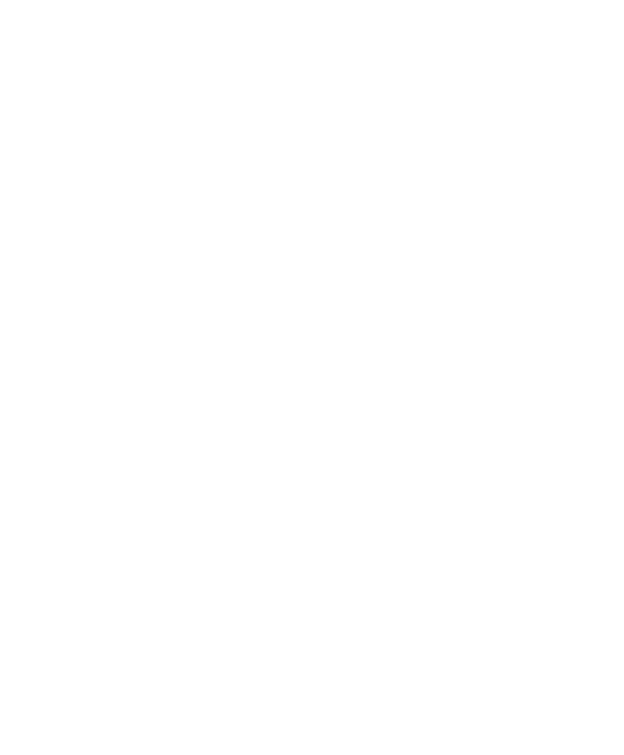I risvolti italiani di una survey sulle pratiche dei VC di diversi Paesi europei condotta da 8 prestigiose Business School
I Venture Capitalist italiani sono molto più prudenti di quelli statunitensi e anche di quelli europei, almeno se si considerano Paesi come Francia, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo e Svezia. Concedono finanziamenti valutando quasi esclusivamente la storia – di successo – dell’imprenditore e poco o nulla il prodotto, la tecnologia e il mercato che vengono loro proposti, quando operano in sindacato lo fanno in prima battuta per condividere i rischi (46,4% dei casi), nelle decisioni sugli investimenti cercano l’unanimità una volta su due e preferiscono venire remunerati con bonus finanziari annuali, meno rischiosi, piuttosto che con percentuali (in genere il 20%) sul capital gain. Sono i principali risultati relativi all’Italia di una survey condotta sulle prassi del Venture Capital europeo da un consorzio di prestigiose Business School del Vecchio Continente, tra cui la School of Management del Politecnico di Milano: Audencia Business School, Vlerick Business School/Ghent University, London Business School, Stockholm School of Economics, Universidad Complutense de Madrid e Univiersité du Luxembourg.
“Nel 2020 è stata pubblicata una ricerca autorevole che fotografava le pratiche dei Venture Capitalist statunitensi. – spiega Massimo Colombo, docente di Finanza imprenditoriale alla School of Management del Politecnico di Milano – Ci siamo chiesti se gli investitori europei si comportassero allo stesso modo o se – viste le differenze storico-istituzionali, la dimensioni inferiore del mercato, ad esempio in Italia, o la diversa governance – ci fossero differenze significative. Abbiamo quindi proposto un questionario simile a tutti i Venture Capitalist noti in Italia, Francia, Germania, Belgio, Spagna, Portogallo e Svezia e abbiamo raccolto 885 risposte (corrispondenti al 44% dell’ammontare degli investimenti di VC nel 2022) di cui 44 italiane, pari a una simile percentuale sul totale”.
Stando all’indagine, in Italia si ricevono molte meno proposte che in Europa: all’investitore italiano “tipico” ne sono state sottoposte circa 400 negli ultimi 12 mesi, contro le 500 dell’Europa. Tuttavia, gli investitori italiani ne accettano una su 43 invece che una su 51, finendo per essere meno selettivi. E il fattore chiave per decidere se concedere o meno il capitale è sostanzialmente il team imprenditoriale: infatti, 8 volte su 10 investono su chi ha già dimostrato di avere una storia – imprenditoriale o manageriale – di successo. “Anche in Europa si considera l’imprenditore, il joker, più dell’horse, il cavallo, rappresentato da tecnologia, prodotto e mercato – commenta il Prof. Colombo -, ma se in quel caso le percentuali sono 53,1% contro 27,6%, in Italia si sale addirittura a 81,6% contro 7,9%. Anche il fit fra investitore e startup e il valore aggiunto che il VC può apportare hanno scarsa importanza (5,3%) mentre in Europa valgono fino al 12%”.
Ancora, nel team imprenditoriale gli investitori italiani valutano soprattutto la passione e il commitment (28,9%) e l’esperienza settoriale (23,7%), cui attribuiscono un peso decisamente superiore rispetto ai colleghi europei, che apprezzano di più la competenza (28,2%) e non tralasciano l’esperienza imprenditoriale (19,3%).
Quanto al valore aggiunto del VC, anche gli italiani, come gli europei, forniscono il maggior supporto alle startup nella creazione di legami con fornitori, clienti e partner, nelle acquisizioni e nel monitoraggio come membri del CdA. Il supporto strategico e operativo, invece, è meno frequente.
Raramente un Venture Capitalist investe da solo, in genere preferisce investire attraverso un sindacato, ma se in Europa lo fa per trovare competenze complementari (38,5%) e in misura minore per condividere il rischio (28,8%), in Italia quest’ultimo aspetto diventa nettamente preponderante (46,4%), mentre le competenze complementari pesano solo per un terzo. La necessità di superare vincoli di capitale scende poi dal 22,4% europeo al 14,3% (in Italia di solito i round sono di entità inferiore).
Nello scegliere i partner del sindacato, la reputazione e i passati successi sono il fattore determinante, sia in Italia (45,1%) che, in egual misura, in Europa (44,9%), mentre l’esperienza settoriale conta decisamente di più in Italia (35,5% contro 22,5%). Al contrario, le precedenti collaborazioni hanno minor peso (3,2% contro 11,5%). Quando poi si tratta di scegliere su quali startup puntare, gli investitori italiani perseguono nella metà dei casi l’unanimità (contro il 32,8% europeo), mentre in Europa si vota a maggioranza (37,6% contro 35%) e la ricerca del consenso pesa addirittura il doppio (25,9% contro 12,5%).