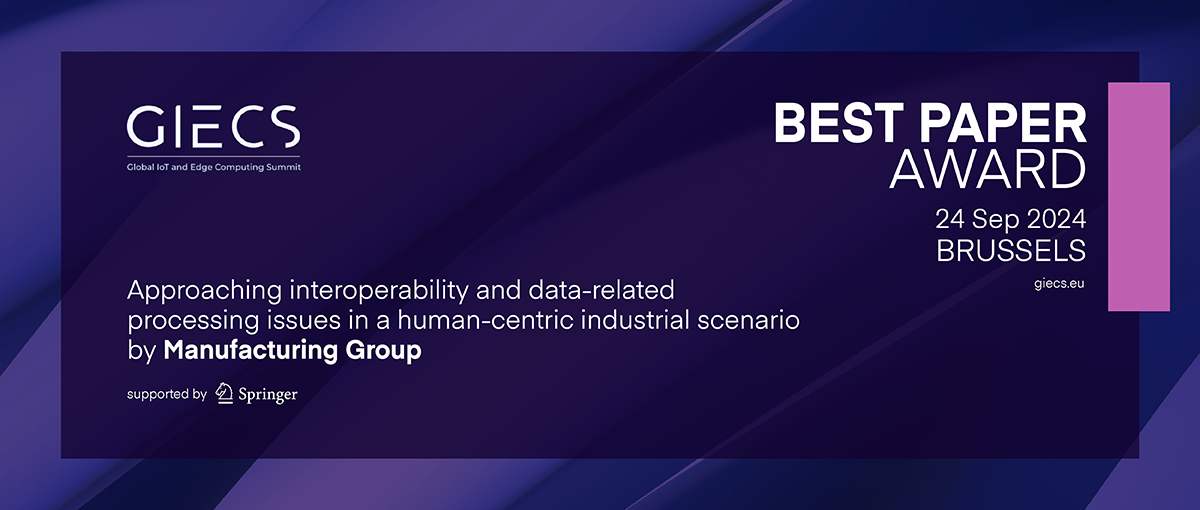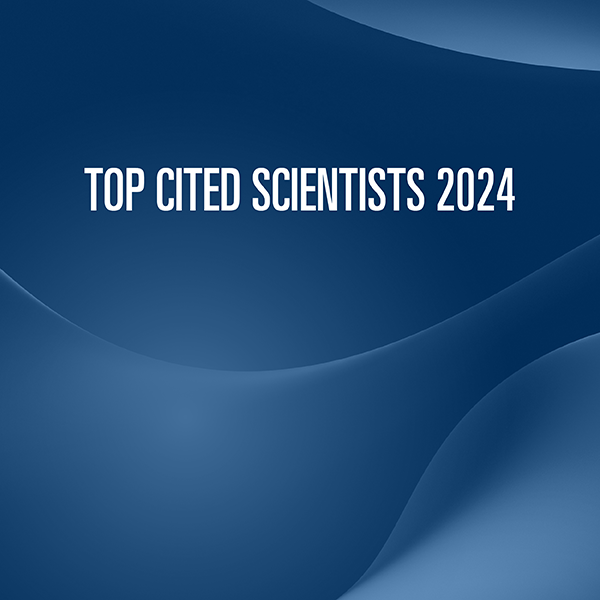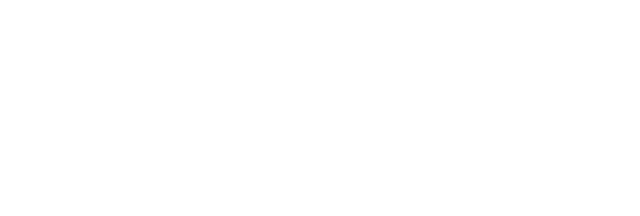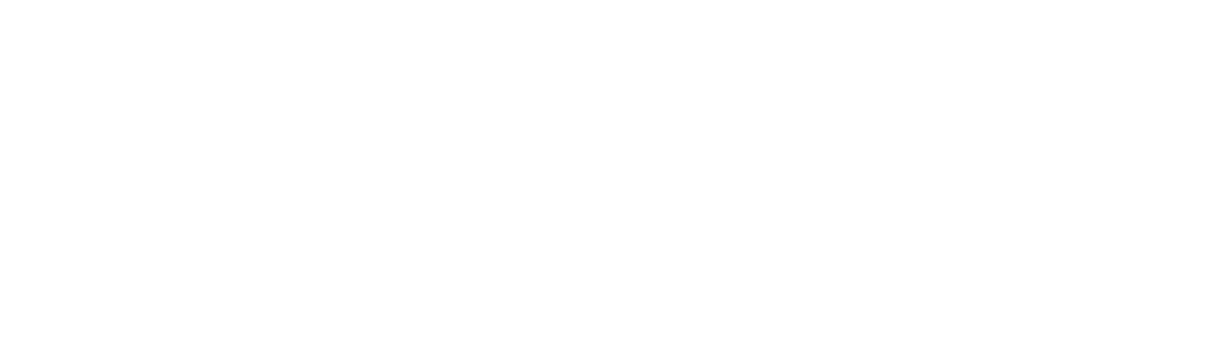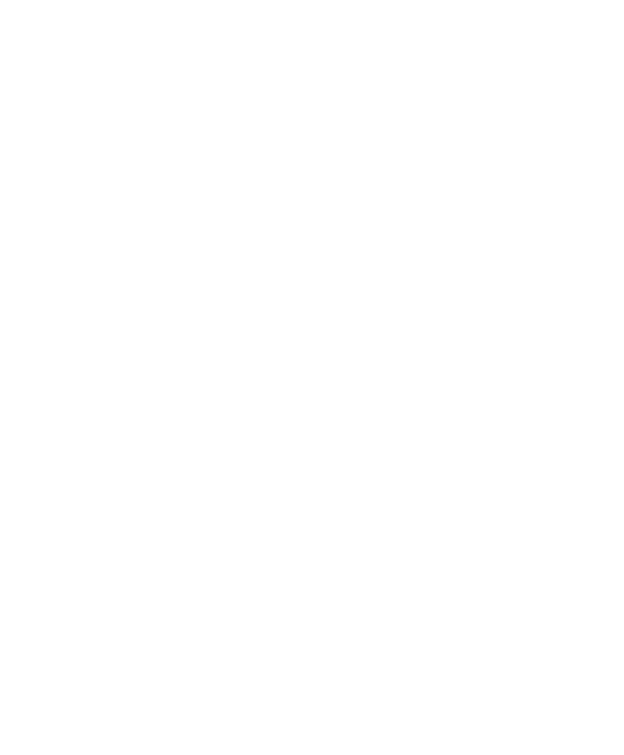Venerdì 20 settembre 2024 si è svolta la cerimonia di conferimento del Dottorato Honoris Causa in Economics and Business Administration da parte dell’Università di Vaasa in Finlandia, al Prof. Roberto Verganti, professore di Leadership & Innovation e co-fondatore del Leadin’Lab alla School of Management del Politecnico di Milano.
Il conferimento del titolo, la cui notizia era stata ufficializzata nel luglio scorso, rappresenta il più alto riconoscimento accademico che l’Università finlandese ha destinato a personalità di rilievo che si sono distinte per i loro contributi scientifici e sociali offrendo benefici significativi all’ateneo e al Paese.
In questa occasione, abbiamo incontrato il prof. Verganti per parlare con lui del percorso che l’ha portato a questo importante risultato.
Il dottorato è ciò che tipicamente segna l’inizio di una carriera accademica. Se ripensi ai tuoi inizi, e alle sfide che hai affrontato, quali suggerimenti daresti al “Roberto del passato”?
Vengo da una famiglia umile nella periferia di Milano. Quando mi fu proposto, dal Prof. Emilio Bartezzaghi, di intraprendere la carriera accademica non avevo idea di cosa significasse. Gli studenti vedono solo la parte formativa di quanto facciamo, ma non sanno quanto lavoro ci sia dietro le quinte. Quando ho iniziato, ero completamente inesperto e non avevo chiaro il percorso che avrei intrapreso. Se avessi avuto tempo, all’epoca, forse avrei dovuto dedicarmi anche alla mia crescita complessiva come persona. Il lavoro accademico, infatti si trasforma presto in un ruolo di leadership. Nessuno mi aveva preparato al ruolo di docente, tanto meno a gestire un team o un’istituzione.
Pensando invece alle sfide che deve affrontare un dottorando che si approccia oggi al mondo accademico e della ricerca, cosa è cambiato? Che consigli daresti ai dottorandi di oggi?
Oggi, se dovessi dare un suggerimento, sarebbe proprio di dedicare più tempo alla propria crescita personale, oltre che impegnarsi nella ricerca e nella formazione.
Consiglio ai dottorandi di prendersi cura della loro crescita come individui, e non solo come ricercatori. Ne beneficia anche la ricerca. Soprattutto in un momento in cui le tecnologie ci pongono sfide sul lato morale non indifferenti.
Pensi che chi comincia il percorso di dottorato adesso riceva questo tipo di formazione?
Non ancora. Parlando del mondo accademico globale (non necessariamente del Politecnico), c’è una crescente attenzione spasmodica alla ricerca e una minore attenzione alla didattica, per cui chi cresce come dottore alla ricerca matura poca formazione alla didattica. Impara un po’ da solo e un po’ per affiancamento ad altri docenti che a loro volta si sono fatti da soli. E soprattutto non riceve nessuna vera formazione alla leadership. Il risultato è che si selezionano e si creano dei ricercatori molto capaci, bravissimi a lavorare da soli, ma che non hanno sviluppato la sensibilità e la sofisticazione del lavoro di leadership e crescita degli altri.
La mia raccomandazione è di prendersi eventualmente più tempo e di non sacrificare la crescita personale e la didattica per voler raggiungere velocemente risultati di ricerca. I ricercatori devono essere innanzitutto donne e uomini di grande sensibilità e profondità. Purtroppo vediamo le università come cattedrali della conoscenza, il che è vero e importantissimo, ma la conoscenza vale poco (o è perfino pericolosa) in assenza di spessore umano. Chi si prende cura di questo?
Che valore dai alla ricerca e cosa significa per te fare ricerca oggi?
Dal punto di vista personale, la ricerca è uno dei lavori più belli al mondo. Ci permette di imparare continuamente, in ambiti che ci siamo scelti, e di condividere quanto abbiamo appreso e la nostra visione del mondo con gli altri. E’ una delle cose che fa più piacere nella vita ed è una grande soddisfazione personale.
Dal punto di vista delle università, la ricerca è il motore che alimenta la capacità di insegnare. Oltre agli articoli e ai brevetti, il contributo più potente che la ricerca offre alla società è attraverso gli studenti che formiamo.
È fondamentale che la ricerca goda di piena libertà, soprattutto in un periodo come questo, segnato da sfide cruciali. Un esempio è la pandemia da Covid-19: grazie all’impegno di alcuni ricercatori, che inizialmente non hanno ricevuto il giusto riconoscimento, siamo riusciti a sviluppare un vaccino in tempi record, uscendo dalla crisi in appena otto mesi. Fortunatamente il mondo accademico è libero, altrimenti Drew Weissman e Katalin Kariko’ non avrebbero potuto procedere (con enormi difficoltà) con la loro ricerca sull’mRNA.
La ricerca può produrre risultati concreti di fronte a ogni tipo di sfida, come ad esempio la sostenibilità, dove è indispensabile trovare soluzioni che riducano il nostro impatto sull’ambiente, o nel campo manageriale, dove il fine ultimo è quello di far sviluppare un pensiero critico che aiuti a guidare le organizzazioni in un mondo complesso.
L’università non dovrebbe essere solo un luogo per apprendere metodi e strumenti, ma piuttosto un ambiente in cui coltivare questo pensiero critico verso ciò che ci circonda. In fondo, sono i leader a tracciare la rotta per il futuro del mondo. Spesso, presi dall’urgenza di insegnare concetti e modelli, rischiamo di dimenticare l’importanza di formare persone capaci di riflettere in modo libero e profondo, uomini e donne in grado di prendere decisioni con una visione più ampia e consapevole della realtà che li circonda.
Oltre a pensiero critico e visione, chi lavora con te ti riconosce una grande curiosità. Da dove deriva questa curiosità e come fare a nutrirla?
La curiosità nasce dall’ambizione e dal sapere di non sapere. Nel sistema universitario c’è sempre la pressione a dimostrare ciò che si sa, ma la vera curiosità è sapere di non sapere, perché permette di scoprire cosa non si conosce.
È la coscienza che ci spinge a fare meglio, a raggiungere un livello di soddisfazione di cui possiamo essere orgogliosi.
Molto della tua ricerca è in collaborazione con le aziende. La vera innovazione nasce da questa sinergia?
Assolutamente. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti manager e tanti leader che hanno accolto l’innovazione design-driven. Quando abbiamo iniziato a fare ricerca ero molto giovane, proprio gli inizi e se ne sapeva poco. E’ stato anche grazie al coraggio di alcuni leader che hanno creduto in noi che è stato possibile sviluppare nuovi approcci all’innovazione.
La ricerca manageriale è pratica e pragmatica: richiede contatto con la realtà, con sfide tecnologiche, ma anche umane. La curiosità e la ricerca del bello sono motori importanti per l’innovazione in azienda.
Ci spieghi meglio che cosa intendi per ricerca del bello? Come si fa a parlare di ricerca del bello quando si fa ricerca con le imprese?
Bello, per me, significa cose che hanno senso, non solo dal punto di vista estetico.
La ricerca del bello ti costringe a porti delle domande profonde, è anche ricerca dell’ambizione e fare le cose con cura. E’ quasi una sensazione fisica, il tuo corpo ti dice che qualcosa non funziona in quello che stai facendo e ti impone di raggiungere un livello di soddisfazione più alto, per esserne davvero orgoglioso.
E’ quella coscienza estetica che ti suggerisce che c’è qualcosa che non funziona, e che invece anela a un risultato più elevato.
In un mondo dove la sostenibilità è la sfida, cercare il bello significa creare qualcosa di cui ci innamoriamo e di cui ci prendiamo cura. In un certo senso è il contrario del consumismo: quando qualcosa è bello e ci tieni, non vuoi disfartene, vuoi conservarlo e prendertene cura.
Guardando al futuro, quali sono i tuoi prossimi progetti?
Sto per iniziare una nuova ricerca con la Stockholm School of Economics su arte e innovazione, per esplorare come l’arte possa aiutare i leader a riflettere e affrontare meglio le sfide dell’innovazione. A sviluppare quella ricerca di senso di cui c’è un enorme bisogno. Un progetto molto stimolante, che spero aprirà nuovi orizzonti.